Volontario anni '90 Parrocchia San Vito Martire, Brindisi.
Abstract
Con cuore semplice e schietto mi accingo a condividere alcuni dei passaggi essenziali della mia formazione umana e cristiana, reggendoli e mostrandoli sul palmo aperto della mia mano così da poterli osservare anch’io, riconoscere e apprezzare mentre li racconto.
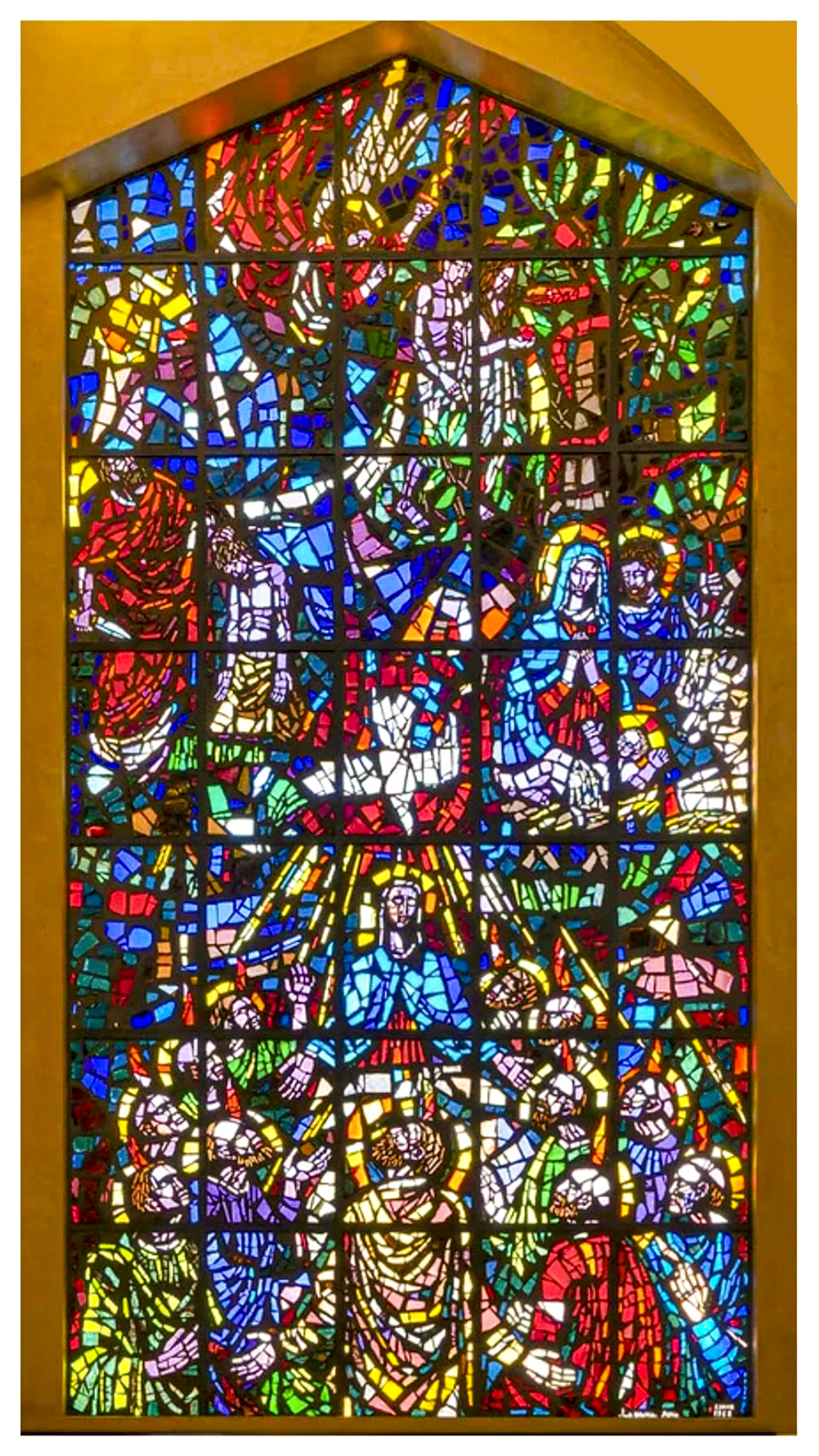
Laboratorio della memoria e del volontariato del Terzo Settore
LabTS Laboratorio di cultura politica del Terzo Settore
Perché e percome
«Pa’, perché non scrivi qualcosa sulle tue esperienze di volontariato in questa parrocchia?»
«Noni, don Peppi’, che devo scrivere? E comunque non ho tempo...»
«Dai, bastano pure due paginette...»
Era il 2012 e la Parrocchia “San Vito Martire” di Brindisi compiva cinquant’anni.
Il parroco di allora, don Giuseppe Apruzzi, aveva condiviso con il Consiglio Pastorale Parrocchiale l’idea di redigere e pubblicare una sorta di Annuario del Cinquantesimo nelle cui pagine custodire e raccontare la storia del primo mezzo secolo di vita della nostra Comunità (...)
Inizialmente provai a svicolare. Poi pensai di scrivere giusto due righe sull’Associazione “Tenda per la pace”, che avevo contribuito a fondare nel 1993 e con cui, per oltre vent’anni, io e i miei amici soci ci siamo occupati di Commercio equo e solidale.
Man mano però che la mia memoria si impegnava a ricostruire quelle vicende e i ricordi trovavano forma e coerenza nero su bianco, sentivo crescere forte dentro di me il desiderio, tutto personale, di estendere i miei “lavori di scavo” a tutto il mio vissuto targato Parrocchia San Vito, col gusto di riportare alla luce i passaggi più significativi dell’intero mio percorso di crescita adolescenziale e giovanile, come persona e come cittadino ancor prima che come cristiano o fedele cattolico. (...)
Agli inizi di quest’anno 2024, il Laboratorio di cultura politica del Terzo Settore ha promosso un corso di scrittura autobiografica avente a oggetto esperienze di volontariato.
Qualche amico mi ci ha buttato dentro e così, pur tra mille esitazioni, ho trovato la forza e il coraggio di tirar fuori dal suo sepolcro telematico il mio lavoro iniziato dodici anni fa: l’ho liberato dalla polvere, l’ho completato, sistemato e consegnato. Innanzitutto a me stesso, al Paolo 53enne di oggi.
Con cuore semplice e schietto, dunque, mi accingo a condividere alcuni dei passaggi essenziali della mia formazione umana e cristiana, reggendoli e mostrandoli sul palmo aperto della mia mano così da poterli osservare anch’io, riconoscere e apprezzare mentre li racconto. (...)
L’accoglienza di Bernardino prima e degli albanesi poi
La sera dell’8 dicembre 1990, solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, la celebrazione liturgica è presieduta dal nuovo parroco della Parrocchia San Vito Martire don Giuseppe Apruzzi (di Ostuni), che subentra ufficialmente a don Giuseppe Convertini, nominato Cappellano dell’Ospedale “A. Di Summa” di Brindisi dal Vescovo Settimio Todisco.
Inizia così l’”era" di don Peppino, la più longeva della nostra storia parrocchiale, così ricca di pazienti semine e preziose mietiture che non sarà facile ricordarne tutti i raccolti, le tante stagioni di lavoro intenso e fecondo.
Parlando di don Peppino vorrei cominciare da quella volta in cui non esitò ad accogliere Bernardino nella sua canonica.
Era una sera di febbraio, fredda e piovosa. Don Peppino aveva preso possesso della dimora parrocchiale da poco più di due mesi.
Bernardino, un "ragazzo" analfabeta, alcolista cronico, con problemi di disadattamento sociale e ritardo mentale, si aggirava ubriaco nei dintorni della parrocchia.
Aveva addosso una vecchia tuta blu, bagnata di pioggia e della sua stessa urina. Camminava scalzo tra le pozzanghere col suo tipico passo incerto, attraversava le strade a casaccio, incurante delle auto in movimento: non sapeva dove dirigersi, forse voleva solo sfuggire a tutti, innanzitutto a sé stesso.
L’avevamo conosciuto qualche tempo prima grazie a don Osvaldo, che lo aveva coraggiosamente avvicinato mentre, in preda alle sue allucinazioni alcoliche, rompeva con la testa gli specchietti delle auto in sosta nei pressi della canonica parrocchiale. Quella volta mio padre, d’istinto, aveva chiamato il 113. Don Osvaldo, invece, francescanamente ispirato, era riuscito ad accarezzare e ad ammansire il "lupo cattivo", davanti ai nostri occhi increduli e intimoriti.
«Don Peppino - gridammo al citofono del parroco io, mio fratello Giorgio e Riccardo - abbiamo recuperato Bernardino che andava in giro ubriaco... è in condizioni pietose... avrebbe bisogno di lavarsi...»
Seduto nella vasca da bagno di don Peppino, Bernardino rimaneva immobile e sembrava il brutto anatroccolo di Andersen: aveva le braccia incrociate sul petto come a proteggersi dal freddo, ma ciò che più lo bloccava era l’imbarazzo di ritrovarsi nudo di fronte a me, che ero entrato nel bagno per assicurarmi che si stesse lavando per davvero. Quando gli chiesi di drizzarsi in piedi per asciugarsi e uscire, mi accorsi che aveva ancora addosso gli slip. «Ma come caspita ti stai lavando?» lo rimproverai assumendo con disinvoltura un tono genitoriale netto e autoritario. E con un gesto deciso a cui lui non provò a opporsi, gli abbassai le mutande rosse e - insaponata una spugna - cominciai a fricularlo (frizionarlo, strofinarlo) energicamente per tutto il corpo.
Nella stanzetta accanto (poi adibita a "sala stampa"), don Peppino ci fece trovare delle generose guantiere di focaccia fumante.
Quella sera, al termine dell’operazione “total wash”, Bernardino aveva un’aria davvero tenera e ridicola allo stesso tempo: il pigiama a strisce verticali che gli avevamo rimediato dal guardaroba della Caritas sembrava più che altro una divisa da carcerato e un paio di mocassini neri troppo grandi per i suoi piedi fungevano da pantofole d’emergenza.
Il bagno caldo lo aveva restituito alla sua coscienza e l’allegra compagnia lo aveva messo di buon umore: facendo il pagliaccio riuscì perfino a scucire a don Peppino un bicchiere di birra.
Per la notte sistemammo due materassi per terra nell’ufficio di don Peppino e io rimasi a dormire lì con Bernardino.
Da allora non l’ho più perso di vista, seguendolo ovunque nelle sue peripezie tra manicomi, case di cura, ospedali psichiatrici, centri di recupero e quant’altro. Per anni ho reclamato la dovuta attenzione nei suoi confronti da parte dei suoi familiari e dei Servizi Sociali del Comune di Brindisi, fino a fargli ottenere ciò che gli spettava per diritto: una pensione di invalidità, una indennità di accompagnamento, una degna sistemazione in una struttura sociale di accoglienza permanente.
Nel 2006 sono stato nominato - dal Giudice Surdo del Tribunale di Brindisi - Amministratore di Sostegno del sig. R Bernardino.
Don Peppino, aprendogli la porta della sua casa, aveva superato brillantemente la sua prima prova di accoglienza. Non sapeva però che, di lì a poco, ci sarebbe stato un altro appello sulla stessa materia, ben più impegnativo del primo, per via delle sue dimensioni, che l’avrebbero poi consegnato alla storia come un evento di portata internazionale: lo sbarco a Brindisi di oltre venticinquemila albanesi, in fuga dalla fame e dalla miseria del loro Paese.
In pochissimi giorni, con una prontezza e un’efficienza da fare invidia alla Protezione Civile, la Parrocchia San Vito Martire si trasformò in un’enorme struttura di prima accoglienza vivendo da protagonista, insieme al resto della città, una delle più belle pagine di solidarietà della storia di noi brindisini.
Negli uffici parrocchiali di Via Piemonte si raccoglievano le scorte dei viveri offerti dalla gente del quartiere e si servivano ogni giorno centinaia di panini imbottiti, che rappresentavano il pasto consueto anche di noi volontari, tanto presi dalla commozione del soccorso fraterno da non ritirarci a casa neanche per mangiare.
Nel vecchio teatro parrocchiale (quello con le sedie in legno) fu collocata una quantità enorme di indumenti e scarpe e s’improvvisarono dei camerini per consentire un minimo di privacy ai tantissimi profughi che avevano bisogno di cambiare i propri vestiti, bagnati e sporchi, con quelli, asciutti e puliti, consegnati in parrocchia dalla stupefacente solidarietà dei brindisini.
Nel cortile gli scout riuscirono addirittura ad allestire un rudimentale impianto idrico in grado di offrire un preziosissimo servizio docce, sia pure all’aperto: gli albanesi sfidarono la rigida temperatura di marzo senza troppi indugi, tanta era la voglia di scrollarsi di dosso il fetore della miseria e riacquistare al più presto il profumo della dignità.
Io ero al secondo anno di università, Giurisprudenza a Bari. Avevo vent’anni, una freschezza e una vitalità pressoché inesauribili, che, senza pensarci su, mettevo volentieri a disposizione degli altri, soprattutto di chi era in difficoltà. Grazie alla Lancia Prisma di papà (che il Signore aveva chiamato a sé già tre anni prima), facevo la spola tra la parrocchia e i vari plessi scolastici presso cui gli albanesi erano stati ricoverati nei giorni dell’emergenza.
Ero presente in particolare al Liceo Scientifico Enrico Fermi, la scuola del quartiere Santa Chiara di Brindisi che io avevo frequentato fino a due estati prima. (...)
Don Peppino aveva avuto il suo battesimo di fuoco. Per immersione totale nel “popolo d’Israele”!
Dalle scrivanie della Curia, dove affiancava il Vescovo Todisco in qualità di Segretario, si era ritrovato – nel volgere di pochi mesi – catapultato in mezzo alla gente, quella più povera, quella più bisognosa di cure e di attenzioni, che andava a bussare alla sua porta di Via Sicilia in qualsiasi orario della giornata, anche di notte.
Gente semplice, non solo del quartiere ma di tutta la città e oltre, capace di esprimere affetto, stima e gratitudine con gesti di amicizia sincera: il dono di una ciambella profumata, di una puddica chena di chiapparini e pumbitori o di una bottiglia di vino casaluru; la promessa di una preghiera, una benedizione, un abbraccio commosso, magari al termine di una confessione delicata o di una visita di condoglianze. (...)
Il cammino di fede nel Gruppo Giovani e la figura di don Tonino Bello
Era entusiasmante la ventata di freschezza giunta alla “San Vito” con l’arrivo di don Peppino, in grado di legare subito col mondo giovanile, a cui sapeva proporre sfide dal sapore autenticamente evangelico e di cui sapeva cogliere e valorizzare la voglia di partecipazione e protagonismo.
Un laboratorio chimico pieno di provette fumanti di svariate fogge e dimensioni e di curiosi alambicchi contenenti distillati di vari colori. Questa era l’immagine di giornale che don Peppino ritagliò e incollò sul grande cartellone bianco per descrivere la mia persona, il mio carattere.
Quella sera, nella riunione del Gruppo Giovani - a cui il parroco soleva partecipare non già in qualità di educatore/formatore, ma di “semplice” assistente spirituale - dovevamo per l’appunto provare a descriverci a vicenda servendoci soltanto di un paio di forbici e di un mucchio di giornali da cui ritagliare una figura, una foto in grado di esprimere visivamente i tratti caratteristici della personalità dei nostri compagni di gruppo.
Con quell’immagine del laboratorio chimico – ancora impressa nei miei occhi – don Peppino alludeva alla mia struttura mentale alquanto articolata e complessa, alla mia spiccata tendenza alla razionalità, dai cui eccessi, sin d’allora, provava, con affettuosa autorevolezza, a mettermi in guardia: «Non puoi pretendere di analizzare sempre tutto, di trovare una formula sperimentata per ogni cosa, di comprendere ogni processo in tutti i suoi passaggi!».
Nel cammino di fede che, come Gruppo Giovani, tentavamo di percorrere in autonomia, tendenzialmente allergici a qualsiasi forma preconfezionata di associazionismo cattolico, grande spazio e considerazione assegnavamo ai temi della pace, della nonviolenza attiva, della giustizia sociale, della mondialità, sforzandoci di coltivare una spiritualità incarnata nella storia e avendo come figure di riferimento quelle di profeti “scomodi” quali padre Alex Zanotelli, don Luigi Ciotti, don Tonino Bello.
I primi due abbiamo avuto la gioia di ospitarli più volte in parrocchia. Don Tonino, invece, in pochi abbiamo fatto in tempo a conoscerlo di persona. Leggevamo con avidità i suoi scritti, capaci di far vibrare le corde più intime dell’anima per la loro straordinaria carica di umanità.
Nella notte dell’ultimo dell’anno 1992, alcuni di noi (io, mio fratello e Gianluca Storelli) andarono a Molfetta, sede del suo episcopio, per partecipare all’annuale Marcia Nazionale per la Pace di Pax Christi, guidata proprio da don Tonino, appena rientrato da Sarajevo, incendiata dalla terribile guerra in corso nei Balcani. Nonostante fosse già gravemente malato di tumore, il Vescovo di origini salentine si era spinto, insieme ad altri cinquecento coraggiosi volontari, fin nel cuore della sanguinosa guerra che stava dilaniando le popolazioni della ex Jugoslavia per chiedere a gran voce il cessate il fuoco e l’immediato avvio delle trattative diplomatiche per la ricomposizione nonviolenta del conflitto.
Prima che don Tonino spirasse nell’aprile del 1993, io, Giorgio e Riccardo andammo a Molfetta per fargli una visita. Ingenui come eravamo (io avevo appena 22 anni), non avevamo preavvertito nessuno delle nostre intenzioni e ci presentammo in episcopio con in mano un grande poster di cui volevamo fargli dono. «Date pure a noi il vostro omaggio, - ci dissero sulla porta d’ingresso i sacerdoti che lo assistevano - il Vescovo sta molto male e non può ricevervi...»
Ma qualcuno di loro, leggendo lo sconforto sui nostri volti, pensò comunque di avvertire don Tonino, il quale diede subito disposizioni perché ci lasciassero entrare. Non ricordo quello che ci dicemmo nella sua stanza, dove l’aria era rarefatta dalla sofferenza che sembrava fuoriuscire dal suo corpo straziato e le nostre parole rischiavano di risuonare goffe e pesanti. Mi è rimasta impressa l’immagine della sua mano, perché quando la strinsi con la mia per salutarlo la trovai gonfia e gialla.
Guidai la Mini Rover della mamma da Brindisi a Molfetta con un braccio ingessato il giorno dei funerali di don Tonino pur di prendere parte anche fisicamente al rito dell’ultimo saluto, unendomi nella preghiera a quanti volevano dirgli grazie per la sua eccezionale testimonianza di vita cristiana.
Un paio di mesi dopo, la sera di Pentecoste 1993, noi giovani della comunità parrocchiale, guidati da don Peppino e seguiti anche da un certo numero di adulti, raggiungemmo le spiagge del litorale brindisino (nei pressi del lido Granchio Rosso) per partecipare alla veglia di preghiera “Fuochi di pace contro fuochi di guerra”: l’idea, che era stata concepita dallo stesso don Tonino, era quella che tutti i credenti dell’intera costa adriatica si ritrovassero quella sera a mani giunte in riva al mare che ci divideva dai Balcani in fiamme per implorare dall’alto il dono della Pace. Prima di ritirarci, affidammo simbolicamente al mare la nostra preghiera, scritta su un pezzo di carta, perché, in una bottiglia di vetro, solcasse le onde dell’indifferenza che crea le distanze e approdasse sulle coste slave col nostro messaggio di pace.
Nell’agosto del 1993 con MIR SADA (“Pace subito”) si bissò la marcia di pace che don Tonino aveva già realizzato nel dicembre del ’92 attraversando i territori in guerra della ex-Jugoslavia: questa volta, però, i volontari da tutto il mondo non erano solo cinquecento, ma diverse migliaia. Tra gli italiani, guidati da don Albino Bizzotto dei “Beati i costruttori di pace”, c’erano anche tre giovani della Parrocchia San Vito: Paolo Di Giandomenico, mio fratello Giorgio e io. (...)
Casa Betania
Chi ha un po’ di confidenza con i Vangeli, sa bene che Betània era il nome di un antico villaggio della Palestina, a due chilometri da Gerusalemme, dove vivevano alcuni amici di Gesù: Lazzaro e le sue sorelle, Marta e Maria.
Se il Messia, percorrendo le strade della Giudea per predicare e ammaestrare le genti, si trovava a passare da Betania, sapeva di poter contare sull’ospitalità e l’accoglienza di questi suoi amici e soleva fermarsi a casa loro per ristorarsi e riposare.
Nell’essere ospitato, Gesù non trovava solo un pasto caldo e un letto, ma – come scriveva don Tonino Bello – anche qualcuno che gli diceva buon appetito e buonanotte. Godeva, cioè, di un’accoglienza fondata sulla relazione, amicale e gratuita, capace di scaldare il cuore ancor prima di riempire lo stomaco.
A questo tipo di accoglienza abbiamo voluto che si ispirasse il nostro piccolo centro, denominato appunto Casa Betania.
All’epoca, la struttura – tuttora attiva e operante nella nuova sede di Via Bruno Buozzi, a poco più di cento metri dalla prima ubicazione – offriva complessivamente dodici posti letto, otto per gli uomini e quattro per le donne.
In caso di necessità, però, la capienza poteva essere aumentata: piazzando brandine in ogni angolo libero, riuscivamo ad assicurare, in emergenza, almeno altri sette, otto posti.
Oltre alle due stanze adibite a dormitorio, maschile e femminile, ciascuna provvista di un bagnetto, la struttura comprendeva un vano per i volontari, con un lettino e un altro servizio, un refettorio, una cucina e un atrio d’ingresso, in cui gli ospiti si ritrovavano per chiacchierare, conoscersi tra loro, guardare la TV.
L’ambiente era piccolo: era inevitabile, dunque, che la qualità dell’accoglienza si giocasse sulle relazioni, più che sul comfort della struttura.
Il centro era aperto 24 ore su 24. Una cinquantina di volontari ruotavano costantemente nei vari turni quotidiani di presenza nella casa, coordinati da un’equipe di responsabili laici più disponibili ed esperti, che operavano in autonomia, sia pure d’intesa col parroco.
C’era chi cucinava, chi si occupava del guardaroba o del bucato, chi faceva le pulizie, chi assicurava la presenza di mattina, chi di pomeriggio, chi – come me – di sera e di notte.
I responsabili avevano il compito più delicato: ascoltare, ascoltare, ascoltare. Tutto ruotava intorno all’ascolto. Il primo contatto, il primo incontro con chi era nel bisogno avveniva proprio nel “Centro d’ascolto", una stanzetta riservata, ricavata ad hoc tra le aule parrocchiali.
All’esito del primo ascolto si stabiliva se procedere o meno all’accoglienza nel centro. Successivamente, curando la relazione d’aiuto, si programmavano con gli ospiti altri momenti di dialogo e di confronto con l’intento di costruire pian piano un rapporto di fiducia, necessario per mettere a fuoco i problemi più profondi nascosti dietro le prime richieste di assistenza, per ricostruire il puzzle del passato, leggere il presente e riprogettare insieme il futuro.
L’obiettivo principale di Casa Betania era dunque quello di accogliere gratuitamente chi, sprovvisto di un tetto, di reddito, di riferimenti affettivi e lavorativi, malato, straniero o profugo in cerca d’asilo politico, alcolista, tossicodipendente, ragazza-madre o prostituta, minore o adulto segnalatoci dai servizi sociali o affidatoci dal Tribunale per la c.d. “messa alla prova”, comunque persona in stato di grave disagio sociale, fisico, psichico, economico o relazionale aveva bisogno innanzitutto di mangiare un boccone e di posare il capo su un guanciale che fosse più morbido di una panchina o di un marciapiede.
Poi, iniziava il lavoro più difficile: mettere la persona ospitata nelle condizioni di riflettere sulla propria situazione esistenziale, per riappropriarsi innanzitutto della propria dignità, a prescindere dai motivi per cui questa, a un certo punto del percorso di vita, fosse stata smarrita o calpestata.
I tempi dell’accoglienza, pertanto, non erano mai rigidi, ma proporzionati alla situazione di ogni singolo caso: l’ospite - di regola - veniva accolto per tutto il tempo che si rendeva necessario perché potesse riacquistare le proprie forze, rialzare la testa, riprendere il proprio cammino o cominciarne uno nuovo, sulle proprie gambe, in autonomia.
Nel frattempo, si provvedeva a individuare le cause che avevano generato il disagio per tentare di rimuoverle, laddove possibile. Altrimenti, si puntava sulla cosiddetta riduzione del danno.
A seconda dei casi e delle diverse necessità, si provava a offrire assistenza sanitaria e legale (visite mediche, ricoveri ospedalieri, regolarizzazione di documenti, acclaramento di situazioni di pendenza con la giustizia), a cercare un lavoro o un alloggio, a ricostruire i legami con la famiglia e con i parenti.
La vita a Casa Betania scorreva come in una grande famiglia: i responsabili del Centro finivano talvolta per assumere i tratti di figure genitoriali, rispettate e autorevoli o, al contrario, odiate, calunniate, talvolta addirittura minacciate.
Ovviamente i problemi non mancavano mai, proprio come nelle nostre case: da quelli economici (Casa Betania si reggeva prevalentemente sulle offerte dei parrocchiani, che si facevano carico anche di pagare l’affitto mensile della struttura) a quelli legati alla convivenza, sia degli ospiti (non tutti erano naturalmente inclini al rispetto delle regole) che degli stessi volontari (nonostante gli sforzi per assicurare a tutti un’adeguata formazione al servizio, restavano inevitabili disomogeneità e differenze di stile, di maturità e di comportamento, che potevano generare attriti e incomprensioni).
Pure non mancavano i momenti di festa: si preparavano le torte per i compleanni, i pranzi o le cene comunitarie in occasione di particolari festività o anniversari, si prendeva parte alle attività educative o ricreative proposte dalla parrocchia, si vivevano insieme le liturgie eucaristiche e alcuni momenti di preghiera, sebbene i credi religiosi, in alcuni casi, fossero diversi.
Casa Betania, che dopo alcuni di attività si è formalmente strutturata in Associazione acquisendo anche il riconoscimento di O.N.L.U.S., operava e opera sul territorio cittadino e provinciale in una logica di lavoro di rete, a stretto contatto con le altre realtà impegnate nel sociale, da quelle istituzionali (Comune, Servizi Sociali, Questura, Tribunali, carceri, Ser.T.) a quelle del privato-sociale e del terzo settore, laiche o ecclesiali (Centro Servizi per il Volontariato [C.S.V.] della Provincia di Brindisi, di cui è socia fondatrice, associazioni umanitarie, cooperative di solidarietà sociale, comunità di recupero per tossicodipendenti, Caritas diocesana, Curia arcivescovile, Centro aperto “S.Vincenzo de’ Paoli”, parrocchie).
Amicizie, contatti, conoscenze accumulatesi nel tempo e accreditate da uno stile di solidarietà umile e disinteressata ci hanno poi consentito di intessere una fitta trama di rapporti di collaborazione con una serie di figure professionali, il cui apporto si rende a volte indispensabile per risolvere determinate problematiche (legali, sanitarie o di altro genere) di alcuni nostri ospiti, italiani o stranieri: possiamo dunque contare sulla disponibilità di medici, avvocati, assistenti sociali, ispettori di polizia, esperti in materia di richieste d’asilo e di immigrazione.
Tutto questo ci ha consentito di vivere con maggiore serenità la nostra vocazione: non ci sentiamo chiamati a trasformarci in “professionisti del sociale”, ma a raccontare l’amore di Cristo per gli ultimi, per gli esclusi, attraverso una testimonianza concreta che arricchisce il nostro percorso di maturazione della fede cristiana affiancando alle dimensioni dell’annuncio della Parola e della liturgia quella del servizio nella carità. (...)