Mantova (Italia). Uno stralcio della prima opera classificata nella sezione Racconti autobiografici della sesta edizione del premio internazionale Thrinakìa.
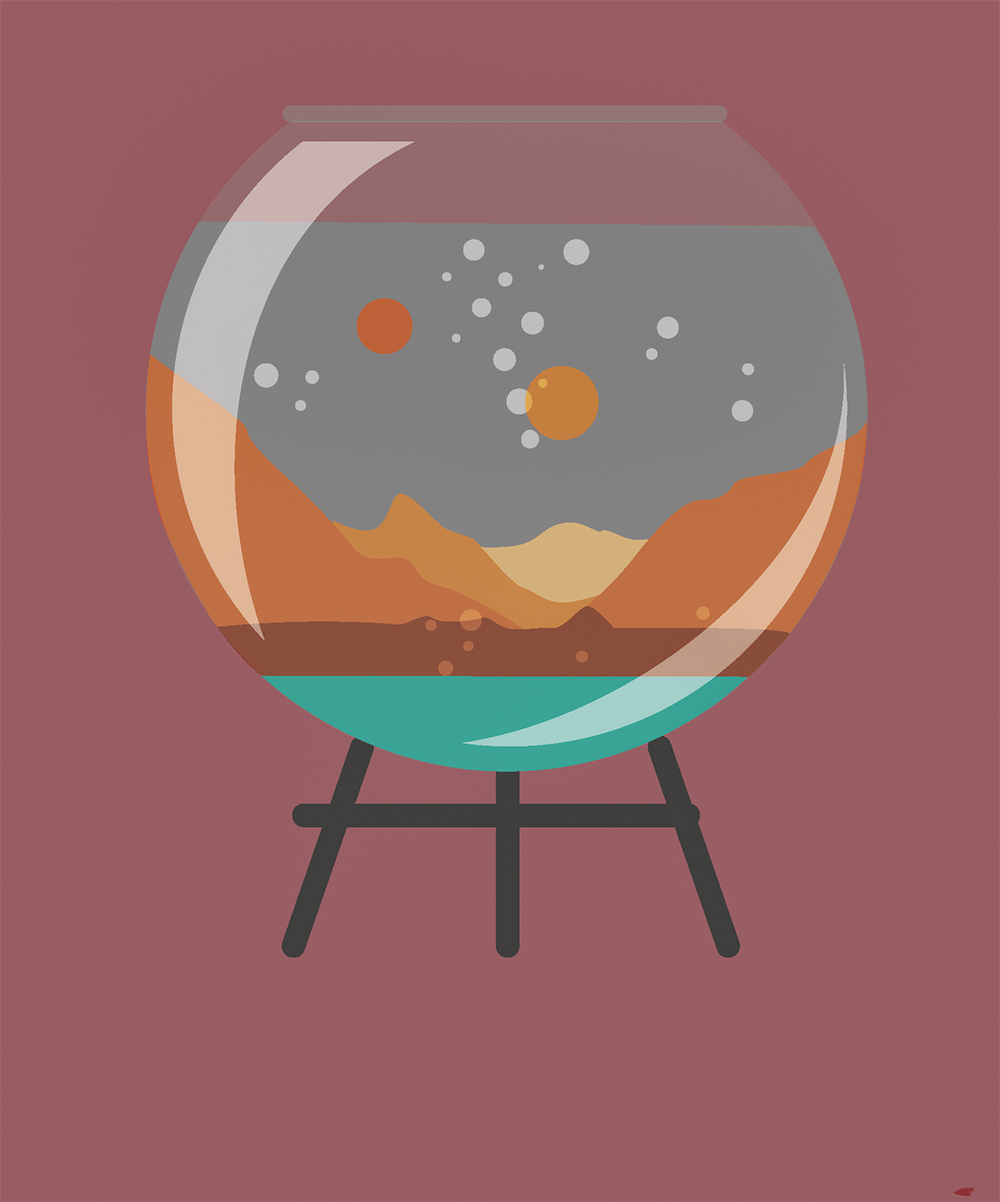
Martina Gobbi, Istituto I.S.I.S.S. Einaudi – Molari di Rimini - Sezione speciale L’isola Thrinakìa. AMIS Archivio della Memoria e dell’Immaginario Siciliano, Le Stelle in Tasca ODV.
Una bara pesa un centinaio di chili scarsi, aggiungete gli altri novanta della salma, metteteci pure la forza fisica depotenziata dal pianto di chi dall’interno della chiesa deve portarla in spalle fino al carro funebre: insomma, non è mica uno scherzo tenere sulle spalle una cassa da morto. E non è un’esperienza piacevole. La scalinata ripida, il clima solenne, i segni della croce che finiscono con il bacio della seconda falange dell’indice della mano che diventa quasi un pugno. Forse anch’io piansi, forse no, di sicuro se lo feci fu più per l’atmosfera tetra e l’aria pesante che si respirava attorno a me che per l’avvenimento in sé: era morto mio padre, indubbiamente un fatto grave e importante, ne riconoscevo la portata storica per le vicende della mia famiglia ma addosso non sentivo emozioni davvero negative, in fondo a me non interessava più di tanto.
Ero un adolescente nel pieno della fase ribelle, andavo poco e male a scuola e non sapevo che ne sarebbe stato di me negli anni successivi. E poi quell’uomo lo conoscevo poco e lo stimavo meno, non era un modello, a lui non mi legavano sentimenti positivi, era stato un criminale di bassa lega che ha aveva fatto la fine del topo, morto in quel carcere di Opera, nel Milanese, in cui odiavo andare una volta a settimana per il colloquio. Mi aveva forse insegnato ad andare in bicicletta? No. O magari a nuotare o farmi la barba quando mi erano spuntati i primi peli tra il naso e il labbro superiore? Macché. Non c’era nemmeno il 9 maggio del 1987, il giorno in cui nacqui, perché lui preferì stare non so bene dove in compagnia di una delle sue amanti.
Si dice che l’indifferenza sia peggio dell’odio: ad essere sincero quel giorno, in una chiesetta alla periferia di Mantova, ero soltanto un ragazzino indifferente nei confronti della morte di un padre. Niente di più, niente di meno.
Della funzione ho memorie sfocate ma credo sia stato un funerale semplice, con la predica del parroco, le preghiere, qualcuno che singhiozza durante l’Ave Maria e cose del genere. Negli anni per lavoro mi è capitato di assistere a riti strazianti con intere comunità in lutto per una bimba portata via da un cancro o per una giovane mamma che perde la vita mentre va a prendere il figlio a scuola: nulla di paragonabile all’addio a mio papà, che definirei standard, senza picchi emozionali particolari. L’interno della chiesa era molto raccolto, l’atmosfera intima e triste ma non disperata. In fondo aveva lasciato questo mondo una persona come tante altre - egoista e che aveva fatto del male a molti - nulla di eccezionale per l’equilibrio del pianeta.
Da adulto mi sono chiesto più volte se la mia sostanziale apatia rispetto a quel lutto fosse stata una reazione di difesa o se magari all’epoca ero semplicemente troppo giovane per realizzare che non avrei più avuto uno dei genitori. Be’, a 34 anni posso affermare con certezza che la prima impressione fu corretta: non ho mai sentito il peso della mancanza di una figura paterna, o meglio, non ho mai sofferto di non avere lui accanto, quell’uomo che conoscevo poco e stimavo meno, perché so che mi sarebbe stato soltanto d’intralcio nel mio percorso di crescita.
Detto questo, provo umana pietà per lui come per chiunque non abbia avuto abbastanza tempo da diventare un anziano con la barba bianca: nessuno merita di morire, per come la penso io. Nemmeno agli esseri più spregevoli si deve augurare la punizione estrema. Dovendo riassumere in un solo concetto, mi spiace che mio padre non sia vivo, ma non per il legame di sangue, quanto più per il dolore che mi causa la sofferenza o addirittura la morte di un estraneo. Sarà che nei primi anni di liceo mi sono ubriacato di libri su Che Guevara, ma tengo sempre bene a mente che un vero rivoluzionario non deve mai cedere al rancore e alla cattiveria ma al contrario essere in grado di provare compassione anche per gli sconosciuti e per chiunque sia in difficoltà. Amen.
In questi anni non sono mai andato sulla tomba di mio padre nonostante il cimitero nel quale è sepolto disti una decina di minuti di macchina da casa mia. Il motivo è molto semplice: sarebbe un atto ipocrita, una forzatura che non mi si addice. Non sono religioso e se pure lo fossi non credo avrei preghiere da dedicargli. Per quanto possa sembrare assurdo io non ricordo la data in cui è morto, nemmeno quella in cui era nato, ma so parecchie cose successe tra i due estremi, e tanto mi basta per derubricare la sua esperienza terrena ad una parentesi che di tanto in tanto affiora nella mia mente mentre sono impegnato a fare altro, sempre e solo quando qualcuno mi pone domande che riguardano la mia infanzia.
È in momenti del genere, mi sarà capitato una decina di volte in tutto, che mi chiedo come sarebbe la mia vita se Nino (lo chiamerei così oggi, non papà) fosse vivo. La risposta non è mai cambiata: mi rispondo sempre che sarei sicuramente meno sereno e con più problemi, senza un grammo di amore ricevuto in più. O potrei non essere vivo, chi lo sa. Perché magari il coltello che il me bambino ricorda a un millimetro dal collo di mio fratello con me sarebbe potuto essere meno clemente. Non era raro che Nino minacciasse mia madre, mio fratello e le mie sorelle per avere dei soldi. Io me lo ricordo bene chi era mio padre.
Dal punto di vista fisico definirei mio padre un italiano medio: non troppo alto, sull’1.75, anche qualcosa meno, carnagione perfettamente a metà strada tra il bianco latte e la pelle ambrata, capelli neri e occhi scuri, con tendenza ad ingrassare dalla mezza età in poi. Per quanto riguarda il peso in realtà ho conosciuto almeno due versioni diametralmente opposte di Nino: l’ho visto magro e con l’espressione sofferente nei periodi in cui era in carcere e decisamente sovrappeso e minaccioso, con una pancia esagerata ma allo stesso tempo comica negli anni a piede libero. Il suo fisico di base era tutto sommato esile, con spalle basse e senza alcun muscolo particolarmente pronunciato, caratteristiche che rendevano ancora più ridicolo l’eccesso di grasso. Sia io che mio fratello sfioriamo il metro e novanta e pure le mie due sorelle sono slanciate: nessuno ha preso da papà. Ci sarebbe poi una terza donna, mia sorellastra, di cui parlerò in seguito, anche lei non certo bassa di statura.
Per essere un delinquente sin dalla giovane età, mio padre non aveva collezionato cicatrici o altri segni profondi che rimandassero in maniera inequivocabile a spericolate attività criminali, anche se in realtà la parte destra della sua fronte era segnata da un taglio rimarginato dal tempo che da quel che so poteva però benissimo essere il risultato di una razione di botte della madre o di una caduta in un cortile polveroso durante l’infanzia. Nino inoltre aveva una leggera zoppia e quella sì - dal poco che mi è stato raccontato - era il risultato di una pistolettata ad una gamba o comunque di “roba di mafia”. Perché in effetti mio padre era un mafioso, dedito soprattutto alle estorsioni e in una prima fase della sua “carriera”, un ladro.
A questo punto immagino che il lettore si stia chiedendo come mai io sia in possesso di notizie frammentarie su aspetti tanto importanti riguardo ad un genitore. Domanda lecita, che ha una duplice risposta. Per prima cosa Nino è morto quando io, l’ultimo di quattro figli e più giovane di dieci anni rispetto a mio fratello, il terzo della cucciolata, ero adolescente e quindi soltanto un bambino negli anni in cui mio padre era nel pieno del cursus honorum nella malavita. C’è poi un’altra motivazione: una volta morto, di mio padre in famiglia si è parlato raramente, in particolare mia madre ha vissuto l’evento come una liberazione, e le poche volte in cui viene nominato non si fa certo riferimento ai suoi reati. A tutto ciò aggiungiamo il fatto che il sottoscritto ha sempre dimostrato scarso interesse per il passato di un padre che non ha mai percepito come realmente tale.
Di lui ricordo un tatuaggio all’altezza del cuore con la scritta "Hayet e Nino" in arabo, in onore di una delle sue amanti (era con lei il giorno in cui io nacqui, non in ospedale con sua moglie). La grafia incerta e il colore verdastro del segno non lasciavano dubbi: quel capolavoro era stato eseguito in galera. Un obbrobrio con cui peraltro il passare del tempo non fu clemente perché il tattoo diventò ancora più brutto quando la pelle e la carne da cinquantenne (poco prima di morire) che non si teneva in forma collassavano ogni giorno di più verso il basso.
Dei quattro figli io sono senza dubbio quello che più ha preso da mio padre, anche se la somiglianza si limita al viso: il naso grande e dritto, l’occhio sinistro leggermente più chiuso del destro, alcune espressioni identiche e le labbra carnose sono segni della trasmissione diretta del Dna. Non a caso quando avevo tre o quattro anni spesso venivo chiamato “Nino il nano”: per i parenti, zii, zie, cugini e cugine ero una versione in miniatura di mio padre e all’epoca il paragone non mi infastidiva, al contrario essere il piccolo di famiglia, il “nano” mi piaceva perché mi faceva sentire come un adulto, uno dei grandi, soltanto non ancora alto come loro.
Altra eredità paterna è la mia deviazione del setto nasale, difetto che costringeva Nino a tenere sempre in tasca delle gocce che, diceva lui, lo aiutavano a respirare meglio: chi non lo conosceva poteva pensare fosse un cocainomane che ogni due per tre ispirava rumorosamente ma in realtà il tic derivava dall’abuso del medicinale miracoloso, tanto più che uno dei pochi pregi di mio padre era il totale disgusto per la droga di cui non mancava di ricordare a me e a mio fratello la pericolosità.
Suppongo che la sua avversione per gli stupefacenti nascesse dalla conoscenza diretta di persone che con schifezze tipo l’eroina ci avevano rimesso la pelle. Inoltre, elemento da non trascurare, Nino era ansioso e spesso ipocondriaco e infatti parlando della droga sottolineava prima di tutto che era un qualcosa “che non ti fa essere lucido, non sei più tu”.
Alla parola “nano” è legato uno dei pochi ricordi divertenti che vedono protagonista mio padre: un giorno tornò a casa ridendo e raccontò a mia madre che mentre stava pescando (una delle sue poche passioni) un anziano gli aveva dato un consiglio su quale esca usare e lo aveva chiamato nano, un appellativo che nel Mantovano è un nomignolo generico e affettuoso, cosa che però Nino ignorava. Quindi, credendo di essere bersaglio di offesa, fece per attaccare rissa tra lo stupore degli altri pescatori che non si capacitavano dello spropositato orgoglio di quell’uomo che non solo non voleva accettare la dritta del compagno di canna, ma addirittura era pronto a menare le mani pur di difendere la scelta di usare un tipo di verme e non un altro. Ci volle un quarto d’ora per far capire a Nino che il vecchietto era animato dalle migliori intenzioni. In seguito i due diventarono amici.
Una delle peculiarità di Nino era sicuramente la condizione di salute perennemente precaria. Il primo infarto era arrivato in carcere nel corso di una partita di calcio che i detenuti stavano disputando nell’ora d’aria. Aveva circa 35 anni. Da quel giorno diventò ufficialmente cardiopatico, termine che gli sentivo ripetere spesso, quasi sempre per trarre vantaggio da una situazione. Uno degli scenari tipici: parcheggiava la sua Opel Kadett blu davanti ad un passo carrabile dicendo che ne aveva diritto visti i problemi al cuore, circostanza non comprovata da un pass per disabili. Di certo, al netto della mancata certificazione da esibire sull’auto, il suo cuore non se la passava bene se è vero che al primo infarto ne seguirono altri due, l’ultimo dei quali gli risultò fatale.
Mio padre era una persona ignorante e non soltanto perché i suoi studi si erano fermati alle scuole elementari. Non aveva mai intuizioni geniali o picchi di interesse per qualcosa. Passava ore davanti alla televisione ingurgitando quelle che oggi definiremo fake news, era un convinto sostenitore di Berlusconi perché in lui vedeva un furbo, uno che ce l’aveva fatta e si era assicurato il Potere. Ad orario di cena immancabile era l’appuntamento con il TG4 di Emilio Fede intento a difendere a spada tratta il suo editore: mio padre non lesinava finti sputi (ma l’odio e il disprezzo erano veri) verso la tv quando appariva un D’Alema o un Prodi. Altro must era Striscia la Notizia: Nino si indignava per gli sprechi di denaro pubblico evidenziati nei servizi e inveiva contro lo Stato, anche se proprio lo Stato gli garantiva un stipendio visto che lui era un collaboratore di giustizia, un pentito e per anni ha ricevuto denaro, oltre ad uno sconto di pena, in cambio di informazioni su Cosa nostra.
Da sempre sorrido sotto i baffi quando qualcuno basandosi su film o libri crede di conoscere la vita di un malavitoso tipo: in verità ne ha un’idea totalmente distorta, come se tutti i criminali fossero Tony Montana in “Scarface”... La realtà è ben diversa, il mafioso medio è mio padre, un essere meschino che se la prendeva con i deboli, metteva le mani addosso alle donne, pretendeva soldi senza guadagnarseli, li rubava agli altri e metteva in pericolo la vita altrui, famigliari compresi, per un proprio tornaconto.
Non esiste alcuna giustificazione per una condotta simile, le origini umili e l’ignoranza non sono attenuanti perché ognuno di noi è artefice del proprio destino. Il fascino del gangster è un mito buono per Hollywood, ve lo assicuro, e per un boss che diventa milionario (ma che magari è costretto a vivere in un bunker sottoterra) esistono chissà quante migliaia di disgraziati senza arte né parte che rovinano le vite delle persone care oltre che degli estranei incrociati nel corso della vita. Al cinema ammiriamo spesso ville lussuose, automobili da sogno, abiti sgargianti e siamo portati a pensare che in fondo, forse, varrebbe quasi la pena rischiare nel tentativo di diventare un criminale: tutte cazzate, mio papà per la maggior parte del tempo era senza un soldo, è morto a 50 anni in galera, girava con una station wagon scassata, non ha mai abitato in una casa da ricco perché ricco non lo è mai diventato e addirittura quando terminò la sua collaborazione con la giustizia fu costretto ad andare a raccogliere le foglie secche per le strade di Mantova per una cooperativa di ex detenuti.
Non nego che la sua esistenza ha conosciuto anche una manciata di giorni di gloria in cui ha potuto spendere mille euro in una serata, ma se credete che basti vivere un giorno da leone ogni due mesi allora non avete idea di quanto squallidi siano i restanti 59 giorni.
A questo proposito mai potrò dimenticare le interminabili giornate passate a letto a farsi servire da mia madre, trasformata in schiava costretta a portargli pranzo e cena a letto, a subire minacce se la bistecca era appena troppo cotta. E badate bene che quella carne era stata acquistata con i soldi portati a casa da lei che si svegliava alle cinque del mattino per un impiego da operaia. In una giornata tipo, poi, dopo cena, capitava che mio padre avesse appuntamento con gli amici con cui andava a gozzovigliare, sempre con i soldi guadagnati da mia madre che doveva nel frattempo mantenere un bambino, cioè io (mio fratello e le mie due sorelle erano già sposati).
Ho ben impresse nella mente le scene di mia mamma che stanca e sopraffatta prepara il bagno per lui che dopo essersi lavato si riempie di profumo e davanti allo specchio indossa la camicia buona mentre ascolta la radio a tutto volume, prima di uscire. Da bambino io parlavo poco ma osservavo tutto e già dalla tenera età, con i pochi strumenti a mia disposizione, capii che la relazione tra i miei genitori era sbagliata e davo per scontato che la maggior parte dei miei compagni di scuola erano più fortunati di me perché stavano crescendo in un’ambiente ben più simile a quello che avevo imparato a conoscere nelle pubblicità dei biscotti in tv.
Seppur nato al mare sono cresciuto in Pianura Padana e il trasferimento dal sud al nord Italia fu piuttosto traumatico. Un pomeriggio mentre addentavo un Cucciolone – avevo cinque anni – mia madre mi annunciò che il giorno successivo avremmo traslocato. Fu di poche parole, non era di buon umore, motivo che mi spinse a non chiedere troppi chiarimenti. Continuai a fare merenda, totalmente ignaro di cosa sarebbe accaduto meno di 24 ore dopo. Fino a quel momento avevo conosciuto alcune case oltre a quella in cui abitavo (mio padre non c’era mai, sempre impegnato per lavoro: così mi dicevano, in realtà era in carcere): spesso dormivo a casa di mia nonna materna, ad esempio, e l’idea di cambiare aria era per certi versi entusiasmante, carica delle fantasiose aspettative tipiche dell’infanzia.
Magari avrei avuto giochi nuovi, una stanza piena zeppa di pupazzi delle Tartarughe Ninja o almeno avrei rinnovato l’esercito dei soldatini così da poter buttare nel sacco della spazzatura quelli vecchi che erano rovinati e con armi tutte uguali, fucili troppo piccoli per le guerre che avevo in mente di sceneggiare sul pavimento della mia cameretta. Probabilmente di notte sognai anche il nuovo cortile che avrei subito trasformato in un campo di calcio ma anche in una pista dove far correre le mie macchinine e far vincere sempre la rossa (una Ferrari?) che era nettamente la mia preferita, ben più carismatica del modellino della Fiat 500 giallo e delle altre concorrenti.
Il grande giorno della partenza iniziò all’insegna della fretta. Mia madre mi vestì in maniera sbrigativa e anche la colazione fu più veloce del solito: latte con il Nesquik e biscotti ma senza neanche il tempo di chiedere il bis, che di solito mi veniva irrimediabilmente negato con la spiegazione che non dovevo mangiare troppi dolci. Di solito incassavo il “no” in maniera tutto sommato sportiva: la mia richiesta da goloso era diventata più che altro un modo per dimostrare l’apprezzamento per il pasto. Da questo punto in poi ho un vuoto di qualche ora e riavvolgendo il nastro dei ricordi mi ritrovo tenuto per un braccio da un carabiniere e dall’altro da mia madre. Ecco come era iniziata l’operazione di trasloco, altro che giocattoli nuovi.
Piangevo, attorno a me c’era un gran chiasso, decine di persone, in divisa e non, molti vicini affacciati alle finestre, grida, sirene che suonavano. Io reagì nell’unico modo possibile: piangendo a dirotto, anche se non sapevo bene perché. Ero in una situazione totalmente sconosciuta, eravamo a pochi metri da casa ma allo stesso tempo in una dimensione parallela e bisognava sbrigarsi anche se ignoravo il motivo di quel trambusto.
Ad un certo punto, all’improvviso, le lacrime che avevo accumulato sul viso dovettero volare chissà dove nel momento in cui, con uno scatto secco, il carabiniere mi prese di peso, come si fa con un oggetto destinato alla cantina e in pochi secondi – quattro o cinque, non di più – percorse il lembo di asfalto che separava il portone di casa da un’auto. Mi ritrovai, sconvolto e sempre più disperato, sul sedile posteriore, in mezzo, con a destra mia madre e a sinistra il carabiniere. Davanti due signori di cui intravedevo soltanto la nuca, quello di destra aveva una lunga coda di capelli neri. La macchina partii a tutta velocità, su un’altra o su altre due c’erano mio fratello e le mie due sorelle. In totale il corteo era composto da cinque o sei mezzi, tutti a sirene spiegate.