Docente a contratto di Antropologia Urbana presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”. Le sue ricerche si focalizzano sull’antropologia del rischio e sull’antropologia del paesaggio, riguardando soprattutto la relazione tra le comunità umane e il loro ambiente, in particolare quando si tratta di territori a rischio. È membro del LAPCOS (Laboratoire d'Anthropologie et Psychologie Cognitives et Sociales, Universitè de Nice Sophia Antipolis, Francia) e insegna in alcuni master Erasmus Mundus+.
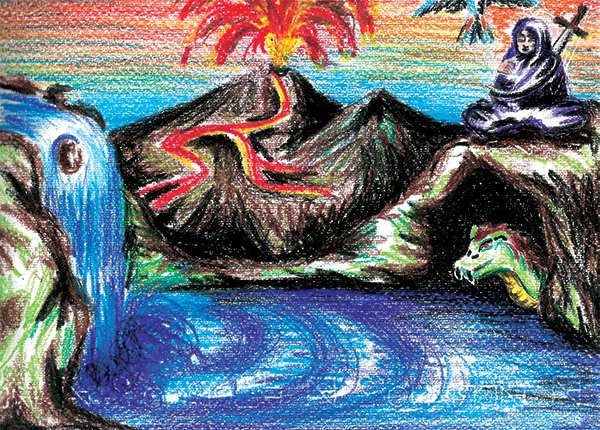
Représentations mythodramatiques de soi
Dessin: Gabriele Gulisano - Lycée Artistique d'État Emilio Greco
Ateliers de l'imaginaire autobiographique © OdV Le Stelle in Tasca
Interpretazioni del disastro
Per secoli nella cristianità i disastri – ampiamente intesi: dai terremoti alle eruzioni, dalle inondazioni alle epidemie – sono stati considerati espressione dell’«ira divina» (Grandjean, Rendu, Scherer 2007). Conseguentemente, per placare il castigo che Dio infligeva agli esseri umani a causa della loro depravazione morale, le popolazioni sinistrate organizzavano processioni, atti di penitenza, esposizioni di reliquie; realizzavano esorcismi, messe cantate, litanie; facevano digiuni votivi, preghiere collettive, confessioni pubbliche. Nei difficili momenti di un’emergenza, in cui la concitazione sovrastava ogni azione, i sopravvissuti non avevano molte altre risposte al di là dei rituali religiosi, specie perché non possedevano particolari conoscenze del disastro (Petit-Breuilh Sepùlveda 2016, 81). Se la convizione generale riconduceva quei fenomeni nefasti al sovrannaturale, allora era piuttosto logico tentare di calmarne la veemenza attraverso specifiche pratiche votive. Ciò ha avuto una sua ragion d’essere almeno fin quando le conoscenze scientifiche non hanno cominciato a spiegare le calamità in maniera diversa. La ricerca delle cause fisiche dei terremoti e delle eruzioni è una questione piuttosto antica a cui si erano dedicati anche i filosofi greci (Bernard 2003); Platone, ad esempio, riteneva i sismi alimentati da fiumi sotterranei d’acqua calda e fredda, mentre Aristotele ne individuava la causa nel vento che spirava sotto la crosta terrestre. Tuttavia, è con l’eruzione del Vesuvio nel 1631 che viene a generarsi una vera e propria «epidemia tipografica» (Scacchi 1882, 70) che, di fatto, segna la nascita della vulcanologia moderna (Galasso 2006, 35).
La comprensione della fisica terrestre, però, necessità di ulteriori passi, per cui bisogna attendere almeno il terremoto di Lisbona del 1755 per separare definitivamente natura e morale: fu un evento oggetto di numerosi studi e svariate interpretazioni (Jacob, Borda d’Água 2007) perché accanto agli scritti di carattere religioso o moralistico, che riesumavano l’antico tema del castigo divino e del memento mori, si sviluppò una riflessione inedita e assolutamente eccezionale sul concetto stesso di disastro, che considerava anche le spiegazioni naturaliste di simili fenomeni. Grazie a tale reazione intellettuale che, all’epoca, vide dibattere i maggiori esponenti della cultura europea, quali Voltaire, Rousseau e Kant (Tagliapietra 2004), il terremoto di Lisbona può essere ritenuto «uno dei luoghi di nascita della modernità perché impone di riconoscere la scissione tra la natura e la morale» (Neiman 2011, 254). Da allora, cioè, «la responsabilità delle nostre sofferenze [va] cercata esclusivamente in noi o, caso mai, in un ambiente naturale a cui noi siamo indifferenti» (Shklar 2000, 65).
Eppure nei secoli successivi, nonostante una supposta razionalizzazione generale (Latour 1995), sono continuate le pratiche votive in caso di disastro, così come proseguono ancora oggi, nel pieno del XXI secolo, in occasione delle più svariate sciagure che, puntualmente, rimettono in causa il rapporto tra natura e cultura. Questo apparente anacronismo permette di rivedere criticamente tanto il rito, quanto il disastro.
Innanzitutto, il rito può essere considerato come un momento “sensibile” della relazione che i gruppi umani hanno con il proprio ecosistema, una sorta di sua “finestra critica”, osservando la quale – sia nei suoi aspetti formali, che in quelli simbolici – è possibile indagare la dialettica con l’ambiente e il territorio. Attraverso il rito, cioè, una società prende «coscienza di se stessa», ma «in modo indiretto, dopo essersi in qualche modo riflessa nel modno materiale» (Fabre 2002, 114). Da questa prospettiva, il rito è una «fabbrica sociale del senso» che marca, controlla, comprende e produce il tempo sociale, lo colloca in una dimensione storica e, per mezzo della ripetizione, ne definisce l’essenza come un incessante momento di emergenza, di risorgenza e di metamorfosi (Fabre 2002, 116).
Parallelamente, il disastro non è un mero accadimento fisico, bensì un processo storico, dunque sociale e politico: «una variegata e disomogenea serie di avvenimenti, accomunati dalla capacità di produrre la percezione di una duratura e sostanziale frattura dell’ordine sociale, delle routine, delle condizioni materiali e del senso di sicurezza propri di “comunità” di estensione variabile, talvolta persino coincidenti col globo» (Saitta 2015, 9). Le dimensioni e l’impatto delle sciagure naturali e tecnologiche degli ultimi tempi, nonché del loro potenziale distruttivo transnazionale, traspecifico e transgenerazionale (Beck 2008, 28-29), hanno condotto a un recupero interpretativo di Voltaire, che invece Goethe aveva relegato a ultimo esponente del mondo antico, dopo Lisbona. Jean-Pierre Dupuy, infatti, oggi riprende una lettura voltairiana del disastro e la proietta «presso i postmoderni, che preferiscono guardare la contingenza in faccia piuttosto che abbandonarsi alle consolazioni finte delle spiegazioni razionalizzanti» (Dupuy 2006, 53). In altri termini, la nostra società sembra riscoprire degli elementi premoderni e proto-moderni apparentemente contraddittori, dal momento che «vi è la forte percezione di come l’agire umano orientato al futuro, al rischio come azzardo, produca o possa produrre conseguenze perverse e catastrofiche nell’ambiente sociale e naturale, vissuti nuovamente come implicantisi e reciprocamente limitantisi» (Pitch 2008, 31).
Gestione del trauma
Il punto di contatto tra rito e disastro dà luogo a quel che ho proposto di chiamare “rito in emergenza” (Gugg 2014), ossia dispositivi folklorici utili a riassorbire lo shock causato da un trauma e, allo stesso tempo, a tentare di tenere insieme una collettività dopo uno sconvolgimento. I “riti in emergenza” sono, al contempo, cerimonia liturgica e manifestazione di socialità volti al contenere l’angoscia: un tentativo di dominare ciò che è indomabile, ma anche una modalità per esprimere sconcerto, incredulità, rabbia e dolore. Detto altrimenti, «i riti in emergenza sono il modo in cui i sopravvissuti cercano conforto stringendosi gli uni agli altri al fine di restare uniti e vincere la disperazione e la disgregazione» (Gugg 2018). Il termine dispositivo va inteso come ciò che ha «la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi» (Agamben 2006, 21), per cui si riferisce non solo alle strutture con una connessione evidente con il potere, bensì a tutti gli strumenti – compreso il linguaggio – che mettono in relazione gli esseri umani tra loro. In tal modo, l’esperienza di un medesimo modo di sentire, durante una crisi profonda, permette ai membri di una specifica comunità di pensare alla loro identità collettiva e di esprimerla secondo procedure che sono, appunto, culturali. Il disastro sconvolge il tempo e lo spazio, le relazioni e gli sguardi; dura nel tempo e mette alla prova non solo i luoghi, ma anche la comunità che li abita, ben oltre la fase di emergenza.
Lo scombussolamento causa una “discontinuità sociale totale” perché accanto ai propri cari si perdono i riferimenti territoriali e i rapporti sociali: la sciagura assume un carattere totalizzante che volge al disordine e allo spaesamento, per cui fa emergere la necessità di un riequilibrio, talvolta di una ridefinizione o, comunque, di un rigoverno – di sé e del gruppo. Ciò apre un tempo di crisi in cui si tenta una ricomposizione territoriale e sociale, con incertezza e attesa, ma anche con dinamismo e potenzialità: si va alla ricerca di ripari, non solo fisici – dalle macerie, dagli agenti atmosferici e dal freddo invernale – ma anche culturali, nel senso che si desidera un modo per elaborare l’accaduto e per tenere insieme passato, presente e futuro; si brama la continuità nelle rotture o, comunque, si fa ricorso a una rete connettiva che protegga dallo sfaldamento e tenga insieme le generazioni. Un primo passo è la «messa in comune del dramma» (Langumier 2008, 47), che da un lato attesta il carattere realmente catastrofico dell’evento e, dall’altro lato, relativizza l’esperienza dei singoli posti in rapporto a quel che hanno vissuto gli altri: l’evento, cioè, viene drammatizzato nella sua globalità, ma allo stesso tempo il dramma individuale viene relativizzato all’interno di un quadro di sventura in cui uno degli estremi è costituito dalle vittime e dai loro parenti. Ciò avviene in svariate occasioni e con diverse modalità: dagli omaggi istituzionali ai riti sacri, dalla costituzione di comitati di sinistrati alle interviste rilasciate ai mass media.
Nello specifico, le manifestazioni religiose hanno un’intensità che dipende dall’energia sprigionata dal disastro (Petit-Breuilh Sepùlveda 2016, 105) e, indubbiamente, vengono eseguite come un modo per cercare di porre fine alla calamità che causa danni o per minimizzarne gli effetti (Guidoboni 1984). Ma quella dei “riti in emergenza” è una categoria ampia in cui è possibile riscontrare molteplici tipologie rituali, spesso molto differenti tra loro: da quelle penitenziali e allegoriche a quelle formali e propiziatorie, prendendo spesso la forma della processione, delle preghiere collettive o dei digiuni.
Intrecciando narrazioni, resoconti e notizie, i testi cronaschistici sui disastri italiani del passato forniscono numerosi riferimenti alle pratiche votive in risposta alle calamità. Per stare a un fenomeno e a un’area circoscritti come le eruzioni del Vesuvio, a partire dal XVII secolo l’invocazione di san Gennaro diventa imprescindibile a ogni risveglio del vulcano. Il consolidarsi del culto è strettamente legato alla frequenza del fenomeno (Padilla Lozoya 2017) perché, dopo almeno cinque secoli di quiescenza, è proprio con il ciclo eruttivo avviato nel 1631 che il patrono di Napoli assurge a principale protettore dell’area vesuviana; trecento anni, fino al 1944, durante i quali la “sfida” tra il santo e il vulcano si è riproposta, in media, ogni sette anni. La prima eruzione, in particolare, è la più catastrofica: si manifesta con una dirompenza totalmente inedita per l’esperienza e la memoria dei contemporanei, che infatti ne vengono fagocitati sia fisicamente (le vittime sono ameno 4000, i danni pressoché incalcolabili, ma con conseguenze terribili per molti anni), sia psicologicamente. Da questo punto di vista, aver fatto ricorso al sacro non ha solo lo scopo di espiare colpe morali e chiedere perdono per far cessare il “castigo divino”, ma ha anche il fine di tenere insieme i sopravvissuti e di gestirne il trauma. In quell’occasione, ogni comunità alle falde del Vesuvio ricorre a uno o più intercessori divini – dalla Madonna dell’Arco a sant’Anna, da San Catello all’Arcangelo Michele –, ma a Napoli, allora capitale del Regno, la figura celeste più invocata è san Gennaro, che già da tempo godeva della reputazione di essere un rimedio contro i pericoli geologici (De Ceglia, 2016).
Come attestano le cronache dell’epoca, durante la fase più drammatica dell’eruzione i fedeli implorano l’aiuto prodigioso con eclatanti atti penitenziali, confessioni pubbliche e automortificazioni simboliche e fisiche: «[i partecipanti alla processione] andorno scalzi, e con una fune al collo, accompagnando la Reliquia di San Gennaro […]. Le particolari processioni delle Verginelle scapigliate, e scalze, le donne piangenti, le congregationi, di nobili, & ignobili, la confraternita di diverse religioni […] andavano con tanta devotione, che parevano la trionfante, e gloriosa compagnia di Sant’Ursula» (Masino 1632, 19-21). Questo atteggiamento è presente anche nei secoli successivi: nel 1872 Matilde Serao descrive così le donne partecipanti a una processione per invocare l’arresto della lava che incombe su Torre Annunziata: «erano scalze, coi capelli sciolti sulle spalle: con le bocche aperte e convulse, per gridare, per singultare, per piangere […]. E il grido era uno solo, delle donne scarmigliate, di quelle che escivano sulle porte, di quelle che si affacciavano al balcone, un sol grido di invocazione delirante: “San Gennaro, San Gennaro, San Gennaro!”» (Serao 1909, 274). Infine, lo stesso sconcerto lo registra, tra gli altri, Emmanuel Roblès nel 1944: «Arrivavano a noi, condotte da una brezza ghiacciata, le urla del centro cittadino, in cui la processione stava probabilmente sfociando nell’isteria collettiva» (Roblès 1994, 93).
Come osserva François Walter, queste celebrazioni devozionali sono «un sistema coerente di gestione del trauma» (Walter 2008, 41), il ricorso a un’àncora culturale che affermi da un lato lo stare insieme nel qui e ora (Padiglione, Lattanzi 2005) e che scongiuri, dall’altro, la deriva dinnanzi al baratro del non-esserci (De Martino 2001) provocato da un evento che, ieri come oggi, nell’esperienza dei singoli supera la capacità umana. Sentirsi uniti nello stesso destino avvicina le persone dal punto di vista empatico, ma anche corporale: le “circostanze esterne” – e non i “sentimenti interiori” – fanno in modo che ci si venga incontro, che si cammini insieme, che ci si abbracci (Apolito 2014).
I “riti in emergenza” rispondono a un impulso, le cui cause sono semplici pretesti, e i cui sviluppi sono mere narrazioni: è inutile cercarvi un senso, piuttosto bisogna osservare cosa accade al loro interno, quel che avviene “tra” le persone che vi prendono parte. All’indomani del terremoto del 30 ottobre 2016 molti abitanti di Ascoli Piceno si sono raccolti spontaneamente davanti alla cattedrale di sant’Emidio, rimasta chiusa per precauzione, per celebrare comunque la messa davanti al tempio di colui che è considerato il protettore dai terremoti nell’Italia Centrale. Per la medesima occasione, lo stesso è accaduto a Norcia, davanti le macerie della basilica di san Benedetto. Similmente, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, alcuni giorni dopo il sisma del 21 agosto 2017 è sorto un presidio di residenti che, nel corso dei mesi, si è progressivamente allargato da una semplice tenda a una grande baracca con televisore, frigorifero, armadi, tavoli, sedie. La particolarità è che tale struttura si trova sul perimetro dell’antica chiesa parrocchiale di santa Maria Maddalena, che andò distrutta dalla terribile scossa del 1883, ma che non è mai svanita dalla memoria collettiva degli abitanti. Costoro, infatti, in questa seconda sciagura vi hanno fatto riferimento per tenere uniti i brandelli di una comunità traumatizzata: «questa gente rimane al Majo perchè si sente smarrita, persa, perchè vuole essere ancora comunità, perchè vuole stare con Franco, con Maria che ha paura pure di se stessa, con Antoniuccio e Ciro, con Duilio e con Fenina che cucina e fa il caffè con Anna a tutte le ore» (Di Meglio 2017). Il loro sforzo non è quello di tenere in piedi una catapecchia, bensì di ricostruie il loro riparo identitario, un rifugio che riconnetta ieri e domani, che sia in grado di alimentare vecchie e nuove socialità.
Rinnovo dell’ordine
Tali pratiche incorporano ulteriori aspetti, perché spesso rivelano un vero e proprio uso politico del disastro: esaminarle significa osservare criticamente la dialettica che una data comunità ha saputo e voluto impostare con se stessa e col proprio ecosistema; come nota Fabio Carnelli, vuol dire disporre di «un punto di vista peculiare per analizzare quelle tattiche dei soggetti volte a ripensare una comunità immaginata, subito dopo il “disastro”» (Carnelli 2015, 136). Dai resoconti d’epoca di alcune eruzioni vesuviane, ad esempio, tali riti sono esplicitamente approvati, se non sollecitati e organizzati, dalle gerarchie ecclesiastiche, tuttavia non mancano casi in cui i promotori sono stati gli amministratori e i politici (o, per la precisione, gli aristocratici), con una evidente strategia volta a radicarsi presso il popolo.
A Napoli nel 1631 «rimasono [durante la notte] tutte le chiese aperte e tutte piene di gente molti per farvi horatione, molti credendo di star più difesi dal pericolo e molti per confessarsi. […] Parve al Cardinale in questo estremo pericolo di fare una processione per condur parimenti la testa e il sangue di San Gennaro alla chiesa dell’Annunziata e così fu fatto» (Manso 1631, cit. in Leone 1994, 287).
A Torre del Greco, la sera del 16 agosto 1682 sono ancora gli ecclesiastici ad allestire una celebrazione religiosa: «non si mancò dal Reverendo Clero, con processione, e lagrime de’ Cittadini, implorare la Divina Misericordia, portandosi la miracolosa Imagine del nostro Santissimo Crocifisso di Santa Maria del Principio [...] e si andò alla Chiesa del glorioso Martire S. Gennaro, nostro Protettore, dove su l’Altare haveano quelli Reverendi Padri esposto l’Ecclesiastico Pane» (Balzano 1688, 104-105).
A Trecase, dopo oltre due secoli, nel 1906 la processione per fermare l’eruzione vesuviana è possibile ancora grazie al coordinamento del parroco: «i cittadini corsero in chiesa dove confortati da un sacerdote locale, don Vincenzo Precchia, e da lui guidati, presero sulle spalle le statue della Madonna Addolorata e del patrono San Gennaro. [...] Fu allora che quasi fuori di senno, qualcuno prima, e tutti in coro poi, gridarono alla Vergine e a San Gennaro: “Ci dovete salvare, salvateci! Salvate il paese o brucerete anche voi con le case nostre”» (Tortora 1906, cit. in Avvisati 2008, 64).
Il ricorso al sacro, quindi, non emerge solo in modo istintivo o impulsivo; anzi, è stato manifestamente sollecitato da figure specifiche, sia laiche che ecclesiastiche. Ciò avviene ancora oggi, come ad esempio a Castel del Rio (Bologna), dove il sindaco Alberto Baldazzi – in seguito al sisma nel Centro Italia del 26 ottobre 2016 – ha inteso recuperare un rito risalente al 1725, anno in cui furono tenute delle preghiere collettive dopo alcuni eventi calamitosi in zona, stabilendo che questo in futuro diverrà un appuntamento fisso: «ogni anno, in occasione dell’antivigilia di Ognissanti, ci sarà la Santa Messa nella chiesa di Sant’Ambrogio e la recita del rosario nell’oratorio della Beata Vergine del Sudore» (cit. in “Il Resto del Carlino”, 28 ottobre 2016).
Sempre in conseguenza di quel terremoto, inoltre, alla fine di gennaio 2017 a Spoleto (Perugia) il vescovo Renato Boccardo ha invitato a digiunare durante tutta la giornata di venerdì 27 e poi ha indetto una processione penitenziale per l’indomani, sabato 28, intorno alle mura di Norcia con l’immagine della Madonna Addolorata estratta dai Vigili del Fuoco dalla basilica di san Benedetto, crollata nel centro cittadino due mesi prima: «nella tradizione cristiana il digiuno ha un posto molto importante e particolare: è una privazione che si offre per rendere gradita a Dio la preghiera. Non facciamo digiuno per raccogliere soldi, ma per chiedere al Signore, creatore dell’universo, di intervenire anche sulle forze della natura. Non è Dio che manda il terremoto: ma Lui, che ha dato origine al mondo, regolato poi dalle leggi della natura che fanno il loro corso, può intervenire per il bene del creato. Con questo gesto vogliamo allora chiedere al Signore di avere misericordia di queste popolazioni e di questa terra ferite dal terremoto. Sarà anche un momento che ci aiuta a capire l’essenziale e a renderci conto che non tutto quello che facciamo è necessario. […] Riporteremo l’immagine della Madonna, molto venerata a Norcia e invocata anche come protettrice dai terremoti, per qualche ora nella sua terra per chiederle protezione sulla gente della Valnerina e liberazione dalla persecuzione del sisma» (cit. in “ADN Kronos”, 26 gennaio 2017).
In questo quadro le destabilizzazioni provocate dal disastro hanno un catalizzatore fondamentale nella fede cattolica e nei suoi rituali, per cui il ritorno all’ordine – obiettivo pressante delle gerarchie ecclesiastiche e politiche – si realizza attraverso simboli e pratiche che garantiscano un riequilibrio: «ricorrere alla religione non implica un paralizzante fatalismo di fronte alla calamità, ma una motivazione e un sostentamento simbolico efficace per l’agire umano volto a neutralizzarne gli effetti» (Jurado 2004, 67). Virginia García Acosta riferisce del sisma che colpì il Regno Unito nel 1580 e della gestione che ne fecero le gerarchie anglicane insieme all’aristocrazia, le quali procedettero a una «confessionalizzazione del disastro», dal momento che gli effetti del terremoto fornirono non solo un’opportunità per rafforzare il sentimento anticattolico, ma anche per consolidare l’identità religiosa anglicana (García Acosta 2017, 69). Con l’istituzione del «Day of Atonement», il “giorno dell’espiazione”, si diede avvio a preghiere pubbliche e canti su salmi, a sermoni e atti officiati dai pastori anglicani (Janku, Schenk, Mauelshagen 2012); una risposta che certamente ha dato conforto alle vittime di quel sisma, ma che ha anche voluto determinare un preciso ordine, una determinata forma di controllo e una chiara affermazione della continuità e infrangibilità del protestantesimo inglese elisabettiano. Come conclude Garcia Acosta, «si è trattato di una risposta con una esplicita intenzione politica» (García Acosta 2017, 69).
L’ordine da ristabilire è metaforicamente eloquente nella struttura stessa della processione, ossia nel rituale “in emergenza” più ricorrente. Se un tempo ciò significava rinnovare anche il timore verso Dio – una concezione delle cose che, evidentemente, contribuiva a rafforzare l’impegno della Chiesa per ristabilire l’ordine costituito nelle comunità sinistrate (Altez 2017, 182) –, oggi, letto da una prospettiva antropologica, il ricorso alla processione significa ribadire ruoli e piani sociali, perché esalta sia il valore intrinseco del gruppo che sfila, sia il prestigio sociale dei singoli partecipanti al corteo, in quanto conferisce e ribadisce legittimità al loro status, ai loro titoli, ai loro incarichi. Ciò avviene perché ogni rito, anche quello “in emergenza”, associa pratiche e discorso, in un ambito gerarchizzato, ovvero in presenza di «un’autorità che ne detiene il senso, avendone essa stessa formulato il codice» (Fabre 2002, 111). Naturalmente, il campo del rituale non è mai immutabile, ma la sua metamorfosi è quella di un fluido molto denso, per cui lo si può cogliere solo in una prospettiva diacronica e, soprattutto, da piccoli dettagli che, talvolta, è possibile interpretare come scintille di rinnovamento a causa di nuovi rischi. Ancora una volta l’area vesuviana fornisce un esempio chiarificatore: nel 2013 a Torre Annunziata, durante i festeggiamenti per la Madonna della Neve, le celebrazioni si sono concluse con le parole di un importante gruppo folkloristico locale, che chiedevano un intervento miracoloso contro la crisi ecologica e sociale: «Mamma della Neve mia, Tu che ti fai portare solo dai pescatori, aiuta la mia casa e anche questo paese. Quando eruttò il Vesuvio e scese la notte, la lava si fermò davanti a Te. Fammi ancora una grazia, Madonna mia, salvami da questa camorra e dall’inquinamento»[1]. L’accenno alla camorra si riferisce agli episodi occorsi durante la festa dell’anno precedente, quando una banda di malavitosi ha esploso dei colpi d’arma da fuoco a salve, scatenando il panico tra la folla. Il riferimento all’inquinamento, invece, proviene dalle accese proteste di piazza degli anni precedenti contro l’apertura di nuove discariche di immondizia all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio in seguito alla “emergenza dei rifiuti” che ha tormentato la Campania – specie il napoletano – durante il primo decennio del Duemila.
I desideri delle popolazioni disastrate sono di dare un senso a quanto accaduto, di tenere insieme le generazioni passate e future ricucendo la frattura causata dalla calamità e, infine, di tornare “a prima” (restando e ricostruendo «dov’era, com’era», ad esempio), dacché il ricorso al rito permette di elaborare, sul piano simbolico, molteplici risposte. Il rito, d’altra parte, è un prisma del sapere, una «risorsa sociale disponibile nel presente» (Mugnaini 2002, 33) che quieta e rassicura, dal momento che prevede gesti noti e parole codificate e, soprattutto, perché unisce i corpi dei fedeli fungendo da espressione di espiazione, nutrimento e rinnovamento (Padiglione, Lattanzi 2005); il rito sembra sempre uguale a se stesso, così da dare l’impressione che tutto possa tornare “come prima”, nonostante lo sconvolgimento del disastro e l’intrinseco, incessante rimodellamento cui il rito stesso si presta a ogni sua rappresentazione – o, se si preferisce, interpretazione.
Protezione simbolica
Come evidenziano le analisi del post-disastro, il ritorno alla “normalità” antecedente l’evento è una finzione, anzi Revet e Langumier (2011) osservano che il costante anelito di ricostruire una continuità si trasforma irrimediabilmente in puntini di sospensione, cioè reagire, rispondere, (ri)cercare un senso dopo che una sciagura rompe il quotidiano di una comunità significa “tornare al futuro”, ossia non è un semplice tornare uguali a prima, ma è un riuscire a immaginarsi diversi. Il rito, dunque, è un modo per affrontare la paura, che è un'emozione ambivalente, dal momento che può contemporaneamente indurre o inibire. Quando non intensa al punto di paralizzare, la paura è una reazione che permette di trovare la risposta adatta a una situazione di pericolo: in presenza di una minaccia fisica imminente, la fuga o, se possibile, la messa in sicurezza dei beni materiali; quando il pericolo mette a rischio la tenuta culturale del gruppo, il rito. In tal senso, la paura è una condizione necessaria per mantenere lo stato di allerta e per attivarsi in azioni di salvaguardia; da forma di vulnerabilità essa diventa strategia di azione per non diventare soggetti passivi: «bisogna restare attori, attivi, trasformare uno spavento subito in un rischio assunto» (Jeudy-Ballini, Voisenat 2004, 25).
Si tratta di un processo che si mette in atto ogni qualvolta «una certa cultura deve misurarsi con gli eventi che sembrano sfidare i suoi postulati» (Douglas 2006, 82), ovvero quando un avvenimento oscuro e imprevisto disallinea il suo ordine del mondo. Così, i rituali messi in opera durante le varie fasi di un’eruzione o di un sisma rappresentano una reazione sociale al disastro volta al contenere l’angoscia, sono un tentativo di dominare il destino o l’indomabile, nonché una modalità per esprimere il senso di shock, la rabbia, l’incredulità e il dolore; sono il modo in cui i sopravvissuti cercano conforto stringendosi gli uni agli altri al fine di restare uniti e vincere la disperazione e la disgregazione. Presentate spesso come manifestazioni superstiziose, esternazioni dell’irrazionalità o dimostrazioni dell’impreparazione dei sinistrati, in realtà tali forme rituali, «quanto meno appaiono ragionevoli, tanto più rivelano la loro necessità» (Cazeneuve 1996, 13). In quest’ottica, i “riti in emergenza” sono da considerare come una manifestazione del culto dalle molteplici finalità: un’elaborazione collettiva volta a dare senso all’accaduto, una pratica che convoglia ed esprime le emozioni generate dalla calamità, uno strumento di ripristino dell’identità collettiva e dell’ordine sociale. Presi nel loro insieme, sono un modello di protezione simbolica che si affianca ad altre forme di adattamento ai disastri e ai rischi, quelle urbanistiche, ingegneristiche, economiche, ecologiche, politiche. Questa antica tipologia di protezione è ancora in vigore e consente una certa coesione sociale per affrontare le tragedie che mettono a rischio sia il sistema di governo, sia il piano ideologico-religioso (Padilla Lozoya 2017, 142).
Se la comunità disastrata, passata la fase acuta della crisi, riconoscerà il “rito in emergenza” come efficace e, dunque, se l’intervento divino verrà ritenuto decisivo per la risoluzione dell’evento drammatico, allora è possibile che negli anni successivi quel “miracolo” venga ricordato attraverso un rito simile, ma di natura piuttosto diversa: il cosiddetto “rito di commemorazione”. Questo va considerato come una forma di memoria collettiva di quanto accaduto, una vera e propria macchina per risalire il tempo, cioè un modo per selezionare il passato e ripresentificare solo ciò che è ritenuto esemplare. La commemorazione, in altre parole, in quanto complesso di azioni, parole e gesti codificati, rappresenta una messa in ordine dei ricordi atta a favorirne la memoria o, per meglio dire, a tramandarne una memoria. Il “rito di commemorazione” agisce “come se” l’intervento divino di allora si compisse ancora, così da confermare e rigenerare periodicamente la comunità. Il rito garantisce che gli effetti di quel “mito” siano resi ancora attuali: rievoca quel che avvenne a beneficio di chi non era presente, in una perpetua elaborazione di senso.
Ciò avviene perché, nonostante le odierne conoscenze tecnico-scientifiche e le attuali strategie di protezione civile, le comunità continuano a porre fiducia nella protezione divina, indipendentemente dal fatto che questa agisca sul piano simbolico. Il rito è un linguaggio intergenerazionale che, in assenza di scrittura, trasmette un sapere sulla natura del territorio, comunica un insieme di informazioni sul modo di affrontarne i rischi, trasferisce una strategia per difendere il gruppo da quel che può minacciarlo. Si tratta di una particolare modalità del fare che permette la protezione e il consolidamento della propria visione del mondo; rappresenta uno specifico patrimonio culturale cui si attinge nel momento in cui diventa necessario affrontare una crisi, ridurre i danni, mitigare i bisogni, guardare la tragica realtà di una catastrofe; un patrimonio che, attivando una protezione simbolica, produce la percezione di una immunità collettiva e individuale.
Bibliografia
Agamben G., “Che cos’è un dispositivo”, Nottetempo, Roma, 2006.
Altez R., “Historias de milagros y temblores: fe y eficacia simbólica en Hispanoamérica, siglos XVI-XVIII”, in A. Alberola e C. Mas (a cura di), “Clima, riesgo y desastre a ambos lados del Atlántico durante la Edad Moderna. Respuestas políticas, técnicas y religiosas”, numero monografico di «Revista de Historia Moderna», Universidad de Alicante, Alicante, 2017.
Apolito P., “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità”, il Mulino, Bologna, 2014.
Avvisati C., “1906: quando il Vesuvio perse la testa”, Nicola Longobardi Editore, Castellammare di Stabia, 2008.
Balzano F., “L’antica Ercolano, overo la Torre del Greco, tolta all’obblio”, Giovan Francesco Paci, Napoli, 1688.
Beck U., “La società del rischio. Verso una seconda modernità” [1986], Carocci, Roma, 2008.
Bernard P., “Qu’est-ce qui fait trembler la terre? A l’origine des catastrophes sismiques”, EDP Science, Les Ulis, 2003.
Cazeneuve J., “La sociologia del rito” [1971], il Saggiatore, Milano 1996.
De Ceglia F. P., “Il segreto di san Gennaro. Storia naturale di un miracolo napoletano”, Einaudi, Torino, 2016.
De Martino E., “La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali” [1977], Einaudi, Torino, 2001.
Di Meglio G., “Un presidio in piazza per sentirsi comunità”, in «Il Dispari Quotidiano», 14 settembre 2017.
Dupuy J.-P., “Piccola metafisica degli tsunami. Male e responsabilità nelle catastrofi del nostro tempo” [2005], Donzelli, Roma, 2006.
Douglas M., “Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù” [1966], il Mulino, Bologna 2006.
Fabre D., “Il rito e le sue ragioni” [2001], in P. Clemente e F. Mugnaini (a cura di), “Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea”, Carocci, Roma, 2002.
Galasso G., “Ire funeste e ingannevoli torpori”, in “Alla scoperta del Vesuvio”, a cura di G. Galasso, Electa Napoli, Napoli, 2006.
García Acosta V., “Divinidad y desastres. Interpretaciones, manifestaciones y respuestas”, in A. Alberola e C. Mas (a cura di), “Clima, riesgo y desastre a ambos lados del Atlántico durante la Edad Moderna. Respuestas políticas, técnicas y religiosas”, numero monografico di «Revista de Historia Moderna», Universidad de Alicante, Alicante, 2017.
Grandjean D., Rendu A.-C., Scherer K. R., “La colère des dieux ou le sens donné aux catastrophes”, in C. Delécraz e L. Durussel (a cura di), “Scénario catastrophe”, Infolio éditions, Musée d’ethnographie, Ginevra, 2007.
Gugg G., “«Mettici la mano Tu!». Emergenza e commemorazione: vecchi e nuovi riti vesuviani”, in G. Ranisio e D.Borriello (a cura di), “Linguaggi della devozione. Forme espressive del patrimonio sacro”, Edizioni Di Pagina, Bari, 2014.
Gugg G., “The missing ex-voto. Anthropology and politics of the devotional practices in the eruption of Vesuvius in 1631”, in D. Cerere, C. De Caprio, L. Gianfrancesco, P. Palmieri (a cura di), “Disaster Narratives in Early Modern Naples. Politics, Communication and Culture”, Viella, Roma, 2018.
Guidoboni E., “Riti di calamità. Terremoti a Ferrara nel 1570-74”, in “Calamità paure risposte”, numero monografico di «Quaderni storici», vol. 19, n. 55 (1), aprile, il Mulino, Bologna, 1984.
Jacob F., Borda d’Água F., “Pourquoi? Vers une nouvelle lecture du tremblement de terre de Lisbonne”, in C. Delécraz e L. Durussel (a cura di), “Scénario catastrophe”, Infolio éditions, Musée d’ethnographie, Ginevra, 2007.
Janku A., Schenk G. J., Mauelshagen F., “Introduction”, in A. Janku, G. J. Schenk e F. Mauelshagen (a cura di), “Historical Disasters in Context. Science, Religion, and Politics”, Routledge, Londra-New York, 2012.
Jeudy-Ballini M., Voisenat C., “Ethnographier la peur”, in “Peurs et menaces”, numero monografico di «Terrain», n. 43, 2004.
Jurado, J. C., “Desastres naturales, rogativas públicas y santos protectores en la Nueva Granada (siglos XVIII y XIX)”, in «Boletín cultural y bibliográfico», 41/65, 2004. Disponibile on-line: https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/926 (consultato il 3 maggio 2018).
Latour B., “Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica” [1991], Elèuthera, Milano, 1995.
Masino M. A., “Distinta relatione dell’incendio del sevo Vesuvio”, Gio. Domenico Roncagliolo, Napoli, 1632.
Mugnaini F., “Introduzione. Le tradizioni di domani” [2001], in P. Clemente e F. Mugnaini (a cura di), “Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea”, Carocci, Roma, 2002.
Neiman S., “In cielo come in terra. Storia filosofica del male” [2002], Laterza, Roma-Bari, 2011.
Padiglione V., Lattanzi V., “Inscrizioni antropologiche. Connessioni deboli, risonanza forte”, in A. Bottini (a cura di), “Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma”, Electa, Milano, 2005.
Padilla Lozoya R., “La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México”, in A. Alberola e C. Mas (a cura di), “Clima, riesgo y desastre a ambos lados del Atlántico durante la Edad Moderna. Respuestas políticas, técnicas y religiosas”, numero monografico di «Revista de Historia Moderna», Universidad de Alicante, Alicante, 2017.
Petit-Breuilh Sepúlveda M. E., “Miedo y respuesta social en Arequipa: la erupción de 1600 del volcán Huaynaputina (Perú)”, in «Obradoiro de Historia Moderna», n. 25, 2016. Disponibile on-line: https://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/article/view/3154 (consultato il 3 maggio 2018).
Pitch T., “La società della prevenzione” [2006], Carocci, Roma, 2008.
Roblès E., “Vesuvio”, Tullio Pironti Editore, Napoli, 1994.
Saitta P., “Eventi complessi. Introduzione a una sociologia dei disastri”, in P. Saitta (a cura di), “Fukushima, Concordia e altre macerie. Vita quotidiana, resistenza e gestione del disastro”, Editpress, Firenze, 2015.
Sannino M., “Canto alla Madonna: «Salvaci dalla camorra e dall’inquinamento»”, in «Il Mattino», 26 ottobre 2013.
Scacchi A., “Della lava vesuviana dell’anno 1631”, in “Memorie di matematica e di scienze fisiche e naturali della Società italiana delle scienze (detta dei XL)”, Tipografia della Reale accademia dei Lincei, Roma, 1882.
Scarduelli P., “Introduzione”, in P. Scarduelli (a cura di), “Antropologia del rito. Interpretazioni e spiegazioni”, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
Serao M., “San Gennaro. Nella leggenda e nella vita”, R. Carabba Editore, Lanciano, 1909.
Shklar J. N., “I volti dell’ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?”, Feltrinelli, Milano, 2000.
Tagliapietra A. (a cura di), “Voltaire, Rousseau, Kant. Sulla Catastrofe. L’illuminismo e la filosofia del disastro”, Bruno Mondadori, Milano, 2004.
Walter F., “Catastrophes: une histoire culturelle, XVIe-XXIe siècle”, Seuil, Parigi, 2008.
Note
[1] Il testo originale è in napoletano: «Mamma ’ra Neve meija, Tu ca te faije purtà sule r’e piscature, aiuta ’a casa mia e ’stu paese pure. Quanno scuppiaije ’o Vesuvio e scuraije notte, ’a lava se fermaije annanz’a Te. Famme ’na grazia ancora, Maronna mija, salvame da ’sta camorra e dall’inquinamento». Si tratta di una rivisitazione della “Tammorriata della Madonna della Neve” di Gerardo Oliva, eseguita dal gruppo “Paranza ’ro Lione” (Sannino 2013).