
Mappe domestiche: la casa e le sue memorie
Marina Brancato (a cura di)
M@gm@ vol.9 n.3 Settembre-Dicembre 2011
CASA: BANALITÀ… OPPURE PAESAGGIO
Augusto Debernardi
augudebe@gmail.com
Presidente Iniziativa Europea (www.iniziativaeuropea.it); Laureato in Sociologia all'Università degli studi di Trento è stato componente dell’équipe del Prof. Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste.
 Qualche annetto fa, in verità potrebbe essere l’anno scorso 2010, proprio
nella Sicilia palermitana venne fuori un manifesto pubblicitario molto
“equivoco”, in rosa. Lo propongo. Con esso si esprimeva un invito a cambiare
stile. L’invito entrava ed entra nella percezione multipla del quotidiano
e così diventa “normale”, banale con qualche cosa che nulla ha a che fare
con il banale, il vacuo. Ma a partire da qualche cosa che colpisce, che
non è comune come la figura in rosa del dittatore del terzo reich. Ci
fu però una reazione anche da parte dell’Associazione dei Partigiani che
scrissero anche al sindaco della città la loro indignazione ed avversione
a questa pubblicità. Il punto di questa comunicazione pubblicitaria è
grosso modo l’abolizione del limite – ovvero ciò che per definizione non
si raggiunge – per cui l’infimo diventa norma. Con un linguaggio un po’
più scurrile e popolare, da angiporto e con un po’ di inferenza induttiva
si potrebbe dire che nella nostra società sarebbe possibile anche svolgere
il ruolo di “rappresentante delle merde finte”. Si troverebbero comunque
clienti anche se esse sarebbero delle copie della merda d’autore, dei
falsi. La merda d’autore, infatti, l’abbiamo già avuta, anzi “merda d’artista”.
Piero Manzoni ne fece 90 scatole nel maggio 1961 e divenne celebre. Le
vendette a peso d’oro (pesavano ca 30 gr cadauna). Ora sono nelle collezioni
di mezzo mondo. Era un modo di shoccare, di strapazzare l’arte.
Qualche annetto fa, in verità potrebbe essere l’anno scorso 2010, proprio
nella Sicilia palermitana venne fuori un manifesto pubblicitario molto
“equivoco”, in rosa. Lo propongo. Con esso si esprimeva un invito a cambiare
stile. L’invito entrava ed entra nella percezione multipla del quotidiano
e così diventa “normale”, banale con qualche cosa che nulla ha a che fare
con il banale, il vacuo. Ma a partire da qualche cosa che colpisce, che
non è comune come la figura in rosa del dittatore del terzo reich. Ci
fu però una reazione anche da parte dell’Associazione dei Partigiani che
scrissero anche al sindaco della città la loro indignazione ed avversione
a questa pubblicità. Il punto di questa comunicazione pubblicitaria è
grosso modo l’abolizione del limite – ovvero ciò che per definizione non
si raggiunge – per cui l’infimo diventa norma. Con un linguaggio un po’
più scurrile e popolare, da angiporto e con un po’ di inferenza induttiva
si potrebbe dire che nella nostra società sarebbe possibile anche svolgere
il ruolo di “rappresentante delle merde finte”. Si troverebbero comunque
clienti anche se esse sarebbero delle copie della merda d’autore, dei
falsi. La merda d’autore, infatti, l’abbiamo già avuta, anzi “merda d’artista”.
Piero Manzoni ne fece 90 scatole nel maggio 1961 e divenne celebre. Le
vendette a peso d’oro (pesavano ca 30 gr cadauna). Ora sono nelle collezioni
di mezzo mondo. Era un modo di shoccare, di strapazzare l’arte.
 L’opera di Manzoni
L’opera di Manzoni
Oggi è quasi tutto uno strapazzo, un infimo che non va a scuotere né il
perbenismo né l’ipocrisia; anzi li fonda attraverso i suoi addolcimenti.
Dunque la banalità del quotidiano, del dejà vu, dell’esperienza può girarsi
(shift) in altro, in composizione. Non è una novità, se si pensa al lapsus
che facciamo nel semplice discorso parlato o scritto. Ciò che è banalità
di errore diventa segno che rimanda a cose ben più complesse.
Così anche la casa, ciò che rappresenta il bene privato più caro agli
italiani, non sfugge a questo andazzo. Abbiamo ben poco da dirci, ben
poco da dire “uffa basta con questo sociale” con “basta con questo assistenzialismo”,
con “basta con questa sociologia civile”. L’argomento è un po’ più complesso.
Molto più complesso perché è ricco di snodi e di rimandi non solo sociologici.
Partiamo dal recente numero della rivista “Fogli di informazione”. La
gloriosa rivista a cui si è dedicato dal suo nascere Paolo Tranchina,
piscologo e psicanalista junghiano, e che fin dagli anni ’70 si è occupata
di diffondere le riflessioni e le azioni della psichiatria di comunità,
del lavoro di trasformazione istituzionale a partire dal gruppo formatosi
intorno a Franco Basaglia e con lui. In questo ultimo numero, nel senso
del cronos, l’attenzione si concentra proprio sul tema della casa, la
casa per chi altrimenti sarebbe oltremodo istituzionalizzato.
Chi scrive questo articolo ricorda che nella sua vita professionale si
è sempre imbattuto in questo problema, quello della casa appunto. Si è
arrovellato con una serie di domande: “come fare a trovare casa agli ospiti
di un manicomio? Come fare a trovare casa agli ospiti – si fa per dire
– del dormitorio pubblico? Come fare a trovare casa per chi si separa
e non ce l’ha più? Come fare a trovare casa per chi scappa da paesi in
guerra o oltremodo poveri? Come trasformare il come in cosa fare e dunque
con quali risorse.”
Tutte domande che anni fa trovavano la distanza abissale dalle attenzioni
delle pubbliche assistenze. Per gli emarginati non erano previsti punteggi
dei bandi per le case popolari, né aveva senso pensarli. Aleggiava su
di essi l’alone che fu piuttosto caro ad alcune persone di CL che mi erano
venute a trovare quando nel 1977 lavoravo ancora al dormitorio pubblico
Gaspare Gozzi di Trieste. Era l’alone o lo stigma proprio della teoria
della cultura della povertà di Oscar Lewis. In sintesi detta "cultura
della povertà" ricorda l’espressione e la trasmissione di atteggiamenti,
condotte, linguaggi e modi di pensiero tipici delle classi subalterne
che, accompagnando l'individuo dalla nascita, lo condurranno alla ripetizione
ed alla reiterazione del suo stato di "povero" socialmente inteso, conformandosi
pertanto all'immagine che di lui ha la società, in una sorta di auto-etichettamento,
di profezia che si auto avvera. Sotto un altro punto di vista è una forma
di secessione socioculturale: il povero accetta di comportarsi da povero,
introiettando la sua condizione di esclusione sociale. Alcuni di essi
la imputeranno alla società, altri alla propria incapacità, altri ancora
a un destino individuale avverso, mentre per alcuni (pochissimi per la
verità), la povertà sarà addirittura giudicata una scelta di vita. In
buona sostanza, il “culturalmente” povero (o quasi povero) non programma
la propria vita e non riesce a sviluppare relazioni sociali e culturali
adeguate a una positiva integrazione sociale, se non all’interno della
sua stessa cerchia. E spesso, il "culturalmente" povero giudica inutile
qualsiasi tentativo di ascendere socialmente per sé e per la sua cerchia
familiare e sociale.
In queste riflessioni ho sempre trovato un senso di autocompiacimento
da parte dell’osservatore, del tipo “che ci posso fare”, “che volete che
vi dica”, “chi è causa del suo mal pianga se stesso” e così via. Tutte
considerazioni funzionali allo stato dell’immobilismo. Non era ancora
il tempo del coefficiente – o indice – messo a punto da Corrado Gini.
Né tanto meno dei diritti di cittadinanza! Il coefficiente di Gini misura
la diseguaglianza di una distribuzione. É dunque spesso usato per misurare
come si colloca il reddito ovvero la sua diseguaglianza. Avremo valore
0 con massimo di uguaglianza e valore 1 con il massimo della disuguaglianza.
Così sull’onda di questi ragionamenti possiamo dirci che a fronte un salario
medio di 750,00 euro mensili per i giovani di oggi gli affitti sono intorno
a 1000 euro mensili (dati CGIL-Sunia, 2011). Dunque i nostri giovani dal
futuro sequestrato si trasformano in “bamboccioni forzati”. A loro sarà
appannaggio soltanto – e non è poco – la resilienza.
L’indice di Gini ci stimola a mettere in evidenza cosa accade a livello
mondiale nel rapporto ricchezza-povertà. É un rapporto che dà vita ad
una figura interessante, da occasioni allegre, di festa. Infatti a livello
mondiale abbiamo il “calice della disuguaglianza”.
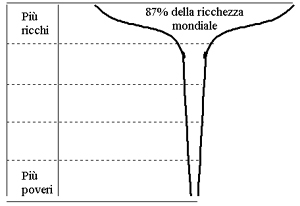 Per l’ Italia
ricordiamo alcuni dati su fonte Istat del 2007. Nel 2006 le famiglie che
vivono in situazioni di povertà relativa sono 2 milioni 623 mila e rappresentano
l’11,1% delle famiglie residenti; si tratta di 7 milioni 537 mila individui
poveri, pari al 12,9% dell’intera popolazione. La stima dell’incidenza
della povertà relativa (la percentuale di famiglie e di persone povere
sul totale delle famiglie e delle persone residenti) viene calcolata in
conformità a una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua
il valore di spesa per consumi al di sotto della quale una famiglia viene
definita povera in termini relativi. La spesa media mensile per persona
rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due componenti che,
nel 2006, è risultata pari a 970,34 euro (+3,6% rispetto alla linea del
2005)” […].Tenendo conto di quanto detto, nel 2006 la stima dell’incidenza
di povertà relativa è risultata pari all’11,1%, valore che, con una probabilità
del 95%, oscilla tra il 10,5% e l’11,7% sull’intera popolazione.
Per l’ Italia
ricordiamo alcuni dati su fonte Istat del 2007. Nel 2006 le famiglie che
vivono in situazioni di povertà relativa sono 2 milioni 623 mila e rappresentano
l’11,1% delle famiglie residenti; si tratta di 7 milioni 537 mila individui
poveri, pari al 12,9% dell’intera popolazione. La stima dell’incidenza
della povertà relativa (la percentuale di famiglie e di persone povere
sul totale delle famiglie e delle persone residenti) viene calcolata in
conformità a una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua
il valore di spesa per consumi al di sotto della quale una famiglia viene
definita povera in termini relativi. La spesa media mensile per persona
rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due componenti che,
nel 2006, è risultata pari a 970,34 euro (+3,6% rispetto alla linea del
2005)” […].Tenendo conto di quanto detto, nel 2006 la stima dell’incidenza
di povertà relativa è risultata pari all’11,1%, valore che, con una probabilità
del 95%, oscilla tra il 10,5% e l’11,7% sull’intera popolazione.
Se si osserva con attenzione la figura del calice della disuguaglianza
si notano alcune particolarità. Se osservate, esso manca completamente
del piede (ossia la sua base)… forse è sottinteso, che sia la povertà
stessa? Penso proprio di sì, cioè quella cosa che porta alla cosiddetta
“autoreferenzialità” del sé – se si segue la teoria di Lewis - per la
stragrande maggioranza degli abitanti umani del pianeta. Tutti coloro
che si collocano nello stelo del calice della disuguaglianza – forse più
simile alla coppa di champagne - sono autoriproduttori della loro povertà!
Così reciterebbe la teoria della povertà. Ma a ben pensarci il peso totale
di tutti coloro che stanno nello stelo – l’80% dell’umanità – fa sì che
detto calice non abbia nemmeno bisogno di una base. Basta l’umanità, non
vi pare?
Qualcosa non quadra. Si potrebbe più facilmente dire di questi ‘poveri’
che sono acculturati, che hanno introiettato valori altrui etc… ma che,
come si sa bene, la povertà può essere ridotta “nonostante” l’identificazione
operativa che si ha con lei! Questo modo di ragionare porta a creare cose
inutili, effimere, auto compiacenti che volgono al ben poco se si instaurano,
invece, delle relazioni volte all’emancipazione ed alla liberazione. Come
nel caso del ‘mio’ lavoro sul campo a Trieste (manicomio e dormitorio).
Per me, per noi la casa era (ed è) il primo mediatore positivo del bisogno
ontologico della protezione o sicurezza. Dove si riproduce il sé. E fa
piacere ritrovare questo senso nella presentazione al n. 17/18 dei fogli
di informazione (terza serie) da parte di Maria Pia Teodori: “la casa
è fondamentale perché risponde ai bisogni primari collegati allo spazio
e quindi all’identità, al senso di sé ed all’autostima delle persone”.
Nella ricerca che la rivista presenta, ovvero una valutazione rigorosa
per l’inserimento in abitazioni” (DSM “F. Basaglia” dell’ASL TO2 e della
Cooperativa Sinapsi) si percepisce la centralità operazionale dell’opportunità
di vivere in luoghi normali per tutte le persone che sono a rischio di
istituzionalizzazione. Programma Case Supportate (PCS) conclude la sua
valutazione dicendo fra l’altro che tutte le persone sono soddisfatte
in termini di qualità della vita. Quale produzione di senso avrebbe attribuire
come proprietà a queste persone inserite in abitazioni col PCS il concetto
di “autopovertà” come diceva l’antropologo americano ancora qualcuno ce
lo dovrebbe spiegare bene. Già, se così non fosse avremmo sicuramente
sentito dire della ‘alta democraticità’ di un\una povero\a nel caso di
un suo matrimonio con un\una ricco\a. Ma non ne siamo stati mai testimoni.
Del contrario lo siamo stati parecchie volte. Non solo. Non ci sentiamo
di denegare ciò che produce l’istituzionalizzazione: la trasformazione
della persona umana in un essere senza diritti, senza soggettività, senza
identità, senza personalità. L’istituzionalizzazione che può essere eterodiretta
come nel caso delle società in cui le ideologie diventano capziose e integrali
oppure coercitiva nel caso delle inclusioni\reclusioni in registri totali
(carceri, manicomi, collegi, caserme…).
La casa, anche quando diventa mediatore dei soggetti “poveri”, entra nella
paesaggistica di una città, di un territorio e diventa momento centralissimo
del paesaggio dei sé. “Paesaggio” è un concetto per cui devo dire grazie
a Carla Gallo Barbisio per lo stimolo che mi ha dato e per la sua formalizzazione.
Mi permetto allora di proporre un mio pezzo su questo punto tratto appunto
dalla nostra rivista “Paesaggi di resistenza” (facilmente scaricabile
in formato pdf, essendo esaurita, dal sito www.iniziativaeuropea.it).
Il paesaggio si costruisce attraverso registri affettivi, estetici ed
azione ed è modellato dai processi metaforici figurati e poetici. Nel
paesaggio avviene il viaggio della vita che non smette mai di creare meraviglia,
dove possibile e impossibile, materiale immaginario concorrono a formare
la nostra identità e l’identità dei luoghi della nostra vita. Il paesaggio
rende più agevole la distanza di colui che studia, che ricerca, che riflette
perché entra come elemento terzo e consente una presa di distanza grazie
alla quale possono prendere forma paure, desideri, sogni, azioni, progetti.
Insomma l’onnipotenza narcisistica può essere abbandonata così come l’egocentrismo
deformante. Il paesaggio come la persona è pieno di ombre, di frammenti
ed è anche disordinato e necessita di un’azione di ricomposizione, di
restauro e di recupero della memoria. Magris lo paragona alla stratificazione
archeologica di segni. Così il paesaggio comincia a dare segni di sé quando
il racconto inizia e dà allora significato e senso dell’umana esperienza.
Si rappresenta, attiva cioè quella funzione della mente che è anche incontro
di operazioni ed affetti, origine di ogni attribuzione di senso, radice
della nostra identità e di quella degli altri. Dare importanza a qualcosa
e a qualcuno significa sottolineare che si desidera che siano conservati
nella nostra mente ed in quella di chi ascolta perché sono riportati all’attenzione
e dunque viene implicato anche il mondo del desiderio inconscio. Il paesaggio
unisce, crogiola, confonde, disvela, coinvolge.
Quando ci fermiamo in un posto sulla superficie della terra e lasciamo
andare lo sguardo e di solito per ammirare o guardare il panorama, come
per far aderire noi stessi al posto e per fissarlo nella sua staticità
nei nostri recettori mnemonici. Si resta anche estasiati nel momento della
vista, la bella vista appunto, nella fissità propria del panorama. Non
appena i nostri occhi, i nostri sensi si abituano e cominciano a riprendere
le loro funzioni che sono quelle della ricerca di stimoli, il panorama
diventa il paesaggio, visione più dinamica alimentata dalle vite che vi
accadono, dai movimenti prima scotomizzati, dalle increspature provocate
dal vento, dallo stormire delle chiome, dal volo delle rondini che sposta
l’aria, dal gioco che fanno le luci e le ombre nel loro rincorrersi, dai
rumori che ti portano a trovare le loro sorgenti e così via. Noi dialoghiamo
con questo paesaggio, in cui coesistono più essenze, più discipline, più
teorie. Il senso dell’ascolto – che è, come dice il prof. Socco che insegna
progettazione urbanistica al Politecnico di Torino, un processo di seriosi
percettiva, di significazione cioè – ci fa scoprire le contraddizioni
ma anche la nostra capacità di affrontarle in modo nuovo per ridurre le
tensioni. Quelle stesse che ci portano i nervi allo scoperto attraverso
i recettori interni ed esterni. I centri del linguaggio si attivano e
ci fanno dire parole che quasi sempre trovano qualcun altro a sentirle
od ascoltare. Il paesaggio diventa rappresentazione quando viene trasformato
in parole, immagini, racconti. Le rappresentazioni danno visibilità e
significato al paesaggio attraverso l’integrazione delle immagini mentali
e le disposizioni relazionali di sé e degli altri e la raccolta ed integrazione
dei contenuti e delle caratteristiche cognitivo-affettive di queste immagini
che si collocano dentro le personali esperienze. E siamo agli sviluppi
di self-identity e place-identity per la costruzione di un’identità a
garanzia di apertura al diverso. Si parte dal paesaggio.
La forma del dialogo diventa la misura della reciprocità in cui ciascuno
ascolta i punti di vista di tutti gli altri del paesaggio e rivede il
proprio in relazione a quanto sentito dagli altri e viceversa, in parità.
Dialogo non è uguale a dialettica, non c’è idealistica contrapposizione,
ma incontro per cercare insieme ciò che non è ancora chiaro e per rimettere
forma al paesaggio che è il nostro “terzo dato”, per mettere a frutto
ciò che è solo intuito e dunque necessità di chiarezza e di rimettere
a posto le visioni.
C’è sempre una mancanza, una necessità, una sofferenza in questo paesaggio
– che è legato alla “nostalgia” (che richiama sempre ed ovunque le nostre
madri originarie) – che vuole ritornare il nostro Paradiso (perduto).
Le cose non accadono per caso, come se ci fosse una intenzionalità dei
luoghi, delle cose, degli eventi, delle azioni. Alcuni studiosi parlano
della inintenzionalità addirittura delle scelte razionali che portano
a stati non voluti e non previsti per riaffermare il primato della razionalità
Comunque ciò che accade può essere narrato. Ecco, l’utilizzo del dispositivo
della parola che permette di predisporre l’azione consapevole che è esattamente
il contrario del passaggio all’atto (quello che molti di voi, di noi,
per intenderci, chiamano ‘raptus’ oppure “gesto folle”) che i più esperti
chiamano anche acting out. Col racconto, col narrare e rinarrare si risolvono
problemi antichi in maniera nuova ed anche creativa.
Attenzione ogni scoperta di “individualità” comporta una frattura – lo
sanno bene gli psicologi dell’infanzia e gli analisti – una separazione,
un distacco. L’io non è più fuso con il materno. L’io è separato dal noi.
E allora la narrazione ha il compito di far vivere il ricordo per conoscere
e per fare accettare al tempo stesso la perdita, il distacco (evitando
così gli acting out). L’identità, di cui oggi si parla molto e se ne abusa
altrettanto, è costruita attraverso il racconto e parte dal Paesaggio
che tutto comprende e fonde nelle origini dove non c’è conflittualità
ma protezione infinita e progredisce dal “me medesimo” (l’invarianza che
mi fa riconoscere dagli altri come me stesso) alla “ipseità” cioè alla
diversità dallo stato originario e dunque mi rende consapevole che posso
essere diverso da come sono (l’ipseità, ha un carattere privato e si coglie
bene nel mantenimento nel tempo di un impegno.) Ed il Paesaggio introduce
la “terzietà” che ci fa ben comprendere che il dialogo non è solo più
tra due persone ma c’è un altro elemento con cui entrare in rapporto.
Dopo l’io ed il tu c’e qualche cosa che rassicura, anzi che è la prima
costruzione simbolica che ci ha fatto sperimentare la bontà dell’altro
(il primo tu) e l’attendibilità del rapporto con l’altro e dunque la incolumità
anche senza l’Azione dell’onnipotenza originaria del me stesso e della
sua fusione simbiotica con la madre. Ed eccoci, così, alla vita libera
e creativa, nel paesaggio, il nostro.
Il paesaggio si guarda, si percepisce, si vive e si racconta. É luogo
della memoria e del tempo, per questo suscita tensioni quando viene offeso.
E le offese sono milioni. Ma se qualche cosa appartiene al paesaggio state
certi che prima o poi viene alla ribalta, si voglia o meno. Nemmeno il
potere più feroce lo può impedire. In breve e il nostro monumento non
intenzionale!
Un esempio concreto, contemporaneo e pratico. Quando si è superato il
manicomio, trasformandone il registro fino alla sua eliminazione legale
ed a Trieste anche pratica – e ricordiamo che legale non vuol dire pratica
– si sono creati dei microcosmi come i centri, gli appartamenti comunitari.
Anzi, una prima micro comunità creata a Trieste nei paraggi del viale
XX Settembre, era stata intitolata a Frantz Fanon (Port-de-France, Martinica
25/7/1925 – Washington 6/16/1961). Gli abitanti di questo microcosmo nuovo
erano persone anziane che già erano state all’o.p.p. e poi al dormitorio
pubblico Gasparo Gozzi.
Alcune persone esterne al processo, compiaciute della nostra mancanza
teorica – così esse dicevano – probabilmente o più semplicemente stupidamente
reazionarie, parlavano di piccoli neo-manicomi. Evidentemente non avevano
la dimensione del “micro” e del “macro” e dunque del microsistema, mesosistema,
esosistema, macrosistema. Nemmeno nel loro essere parlamentari o dirigente
aziendale. (ma questa è un’altra storia).
Possiamo dire che solo apparentemente la casa è questione di banalità
quotidiana, essa è a pieno titolo questione di paesaggio e dell’universo
dei diritti di cittadinanza. Non è un caso oggi che a fronte di risorse
limitate si scatenino tentativi di eliminare dalle scene dei diritti cittadini
più a rischio povertà come gli immigrati. Certo, vengono posti dei problemi,
ma non è certo con l’esclusione la soluzione ad essi. Quando operavano
avevamo visto che per una città di 200mila abitanti un 6/7mila abitazioni
erano sfitte, non abitate. Certamente non tutte erano abitabili, ma sicuramente
potevano rappresentare un più che sufficiente monte “risorsa-abitativa”.
Il punto è piuttosto una questione di leggi e di dispositivi amministrativi.
E sarebbe così facile trovare sia il numero e sia l’esatta ubicazione
delle case libere, non usufruite. Con l’analisi dei contatori dell’acqua
si raggiungerebbero dei numero altamente attendibili e significativi.
Infatti quei contatori che non segnano mai nessun consumo di acqua indicano
facilmente l’assenza di vita in quelle mura! Ecco un modo di raggiungere
un altro limite, non con la pubblicità ma con l’osservazione di un banale
contatore dell’acqua. L’infimo come indicatore di una qualità possibile,
per nulla effimera e per questo temuta. Come la casa, come il bene più
anelato ed amato dagli italiani e per il quale si inventò la prima imposta
patrimoniale dell’era contemporanea (ICI) ed ovviamente a carattere federalistico
(comunale, appunto).
Nel libro “Le reti di pietra: dai residui manicomiali alle pratiche e
modelli per il superamento. Sociologia clinica e pratica psichiatrica”
(ediz. Centro di documentazione di Pistoia, 1997) che ho curato indicavo
appunto un percorso possibile per la totale de istituzionalizzazione in
abitazioni e\o residenze familiari di tutti gli ospiti che componevano
i cosiddetti residui manicomiali della regione Friuli Venezia Giulia.
Fra scuole dismesse, colonie, case, foresterie, latterie sociali etc.
etc. i volumi non solo sarebbero bastati ma sarebbero stati iper abbondanti!
E solo considerando i beni di proprietà pubblica.
Con lo studio dal titolo “il nuovo habitat possibile: pianificazione e
transistituzionalizzazione dei residui manicomiali, curato dall’ing. Franco
Shenkel indicavamo i percorsi possibili. No, non eravamo ingenui, eravamo
potenzialmente degli amministratori accorti. O meglio, eravamo persone
che utilizzavano la loro creatività connettendo, orientando, unendo elementi
pre-esistenti in combinazioni nuove, utili. Banalmente utili. Utilizzando
il disordine che altrimenti è spreco, utilizzando, nella fattispecie,
il disordine lasciato dal mancato uso, da dismissioni di fatto di molte
cubature edili, riconvertendole ad altri usi: case per chi ne era sprovvisto,
case per chi era stato per anni ed anni in manicomio. Accorti ed attenti
a sviluppare e riutilizzare le risorse esistenti riconvertendole senza
ricorrere ad ondate di cementificazione. E ciò vale ovunque, purtroppo.
I mediatori dei bisogni ontologici come nella fattispecie la “casa” mettono
in moto le ombre dei paesaggi e spesso, troppo spesso ne rimangono oscurati
ed inerti. Ma così facendo mettono anche in evidenza non tanto la spinta
antipolitica, quanto piuttosto l’incapacità della politica di affiancare
ed usare le nuove professionalità che emergono nel territorio. Vuoi per
conflitti di interessi, vuoi per timore di svolgere la funzione di empowerment
altrui fatto è che le nuove professionalità vengono rigettate. Eppure
si sarebbe trattato di rigenerazione urbana di un ampio territorio, di
mettere in campo azioni generatrici di rinnovamento con potenzialità molto
aperte ma certamente incisive, anche sul sistema di sviluppo., a partire
dall’edilizia, dalla casa.
Oggi, la testimonianza a riguardo della “casa data a persone con problematicità”
necessita del ricorso al metodo scientifico. Ce lo racconta la rivista
dei “fogli di informazione” che cito all’inizio della presente narrazione.
Come se i diritti dovessero sempre subire verifiche e sempre essere messi
in forse. Insomma… i poveri, i malati, gli emarginati non riescono mai
ad essere “molto democratici”. Né l’estabilishment ad essere altrettanto
molto democratico nei loro confronti. Nel processo di concretizzazione
dei diritti (a vivere in una casa) ricordiamo che alcuni anni fa l’assessora
della regione F.V.G. ai lavori pubblici ha raccolto e proposto con successo
una idea nostra e del sindacato CISL: dare contributi per installare ascensori
nei condomini dove risiedono persone anziane e\o invalide. Era Federica
Seganti. Da parte mia poi, come presidente dell’ITIS ho finanziato e fatto
progettare il “condominio solidale” dove anziani potevano vivere in appartamenti
improntati alla domotica e con vicini parenti o giovani attraverso un
contratto che prevedeva una relazione di aiuto e di solidarietà. (sono
passati ca. dieci anni ma non è stato mai realizzato). Ed oggi assistiamo
a come la medicina e con essa la psichiatria moderna incorra in quello
iato terribile dove c’è la guarigione da un lato (tipo il San Raffaele
di Don Verzé dove filosofi laici ed accorti insieme a scienziati importanti
cercano di liberarci dalla “morte” producendo però un miliardino di euro
di debiti) e dall’altro c’è la cura (che nel paradigma cattolico è ben
simbolizzato da Madre Teresa di Calcutta dove la febbre è curata attraverso
la persona con una pezza bagnata). Ma curare, terapia cioè, vuol dire
appunto “venerare”. Venerare l’altro, con tutti i suoi bisogni. Anche
con la “casa”.
In un mondo in cui diventa difficile immaginare cosa significhi davvero
il fallimento di uno stato – non solo la sua insolvenza, cioè default
ma proprio il bankruptcy o failure – in quanto quegli abitanti saranno
sempre lì e non saranno invasi manu militari o selvaggiamente resi sudditi
altrui (!?) ed in cui vediamo l’osannato Rupert Dylan Murdoch in seri
guai a causa di concussioni e intercettazioni illegali e dove alcuni media
americani mettono in dubbio la moralità di acquisire audiovisivi da tale
company che si è aggiudicata una imponente commessa per le scuole newyorkesi;
in un mondo in cui però non vediamo e sentiamo alcuna remora in chi si
atteggia a fashion guru o compra kashmir o cachemire da imprese i cui
rampolli nemmeno passono gli alimenti al figlio secondo le sentenze dei
giudici, riproporre la questione del diritto alla casa, dei diritti al
soddisfacimento dei bisogni, del diritto a vivere una vita felice e condizionata
dall’esigenza di conformare un equilibrio compatibile e soddisfacente
fra l’oggi ed il domani non è banale. Pensare un mondo, un paesaggio globale
cioè in cui la lezione di John Stuart Mill “non c’è libertà se c’è danno
per gli altri”, nonostante la sua adesione all’utilitarismo, non sia obliterata
come i biglietti dei mezzi di trasporto come invece sembra non è banale.
Anche se l’estensione del banale trasforma le oligarchie in cose da tempi
addietro e fa sì che nessuno si renda più conto del loro livello e capacità
di determinare comportamenti ed atteggiamenti omogenei e diffusi. D’altro
canto, e ricordiamo J. S. Mill, una persona che crede molto in certe cose
vale come novantanove persone comuni per confortarci che non tutti i giochi
sono conclusi anche se difficili. Allora i bisogni come la casa cioè la
protezione, come l’affetto, come la sopravvivenza, come l’espressione
del giudizio e la comprensione, come la libertà, come la partecipazione,
come la creatività, come l’ozio, come l’identità restano i bisogni fondamentali
che chiedono risposte ed equilibri attraverso mediazioni positive e non
negative o violatrici.
Resilienza allora… cioè attivazione delle nostre capacità ed organizzazioni
affinché si possa resistere e sopportare lo stress, come fanno i metalli,
per sviluppare qualche cosa d’altro e come hanno dimostrato gli studi
longitudinali sui bambini poveri per sviluppare adattamenti diversi e
non per questo tendenti al minus, anzi capaci di non farsi determinare
dai fattori di rischio e dai determinanti ipotizzati come tali.


 DOAJ
Content
DOAJ
Content
newsletter subscription
www.analisiqualitativa.com